La flotta tedesca si suicidò così
autoaffondandosi a Scapa Flow

Baia di Scapa Flow, isole Orcadi; 21 giugno 1919, mezzogiorno trascorso da pochi minuti. La corazzata tedesca SMS Friedrich der Grosse, 27mila tonnellate di stazza, si inclina visibilmente a dritta. Nei minuti immediatamente successivi, anche le altre navi da guerra cominciano a colare a picco. L’agonia della flotta germanica prosegue fino alle cinque del pomeriggio, quando infine si inabissa l’incrociatore da battaglia SMS Hindenburg. Forse il più incredibile episodio nell’intera storia della marineria ha avuto il suo epilogo. L'inizio di questa vicenda risale invece all’11 novembre 1918, giorno in cui – con la firma dell’armistizio di Compiègne – finisce ufficialmente la prima Guerra Mondiale.Le condizioni poste dall’Intesa sono durissime, ma al comando germanico non rimane che piegarsi al volere dei vincitori: l’impero austroungarico si è dissolto, la Germania è in preda alla rivoluzione e il Kaiser è dovuto fuggire in Olanda. Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti hanno già trovato un accordo in merito alla resa senza condizioni della flotta sottomarina tedesca, ma non sono coesi riguardo il destino della flotta di superficie, che conta ancora un cospicuo numero di unità da battaglia pienamente operative.
Alla fine della Grande Guerra i vincitori decidono le sorti della Hochseeflotte
Tra gli alleati serpeggiano i primi contrasti e la proposta avanzata dagli americani, ossia di internare in un porto neutrale le navi tedesche, in attesa di una decisione concorde, non viene accolta; l’ammiragliato britannico, forte anche della propria supremazia numerica, decide allora di condurre la “Hochseeflotte" nella rada di Scapa Flow, sede della maggior base navale britannica. Il 12 novembre il comando tedesco riceve l’ordine di prepararsi a far salpare la flotta entro pochi giorni: gli U-boat – ben 176 unità – si devono arrendere al contrammiraglio Reginald Tyrwhitt e saranno quindi internati nel porto di Harwich, lungo le coste dell’Essex, mentre le navi dovranno raggiungere la baia scozzese del Firth of Forth e consegnarsi all’ammiraglio David Beatty, comandante in capo della “Grand Fleet". Da qui, la flotta di superficie – disarmata e con a bordo equipaggi ridotti – verrà scortata fino a Scapa Flow. Per i tedeschi il momento è drammatico: durante la guerra, infatti, la flotta imperiale si e ben comportata, soprattutto nell’epica battaglia dello Jutland, dove ha affondato ben 22 unità inglesi. Gli ufficiali sono furiosi, perché l’internamento in acque britanniche e non neutrali, equivale a una resa ignominiosa: una delle più potenti flotte al mondo, imbattuta, viene gettata nel disonore per il tradimento della propria classe politica. Anche nell’ottica dei marinai, che addossano all’esercito e ai generali la responsabilità della sconfitta della Germania, i termini della resa costituiscono un’onta e il malumore è a un passo dal trasformarsi in sedizione. Inoltre, i fermenti sociali in atto nella società tedesca coinvolgono anche la Marina Militare; il 29 ottobre l’ammutinamento di due navi an- corate nel porto di Wilhelmshaven, i cui equipaggi si erano rifiutati di obbedire agli ordini insensati provenienti da Berlino, era degenerato in una ribellione popolare di impronta socialista, estesasi come un incendio a gran parte del Paese. In queste condizioni, l’ammiraglio in capo della flotta tedesca d’alto mare, Franz von Hipper, eroe della battaglia dello Jutland, si rifiuta di guidare le sue navi verso l’internamento e affida l’ingrato compito al contrammiraglio Ludwig von Reuter. Il 21 novembre i vascelli da guerra germanici cominciano a radunarsi nel Mare del Nord e, scortati da ben 370 unità alleate, si dirigono verso la Scozia. Giunte nel Firth of Forth, per le navi tedesche arriva il momento dell’umiliazione: l’Ammiraglio Beatty, infatti, dà l’ordine di far ammainare la bandiera e di non issarla più. Come avrebbe scritto von Reuter anni dopo: «Fummo disarmati e disonorati». Nei giorni successivi la “Hochseeflotte" è infine trasferita nella rada di Scapa Flow, dove vengono ormeggiate le 74 navi.
I marinai tedeschi sono prigionieri sulle loro navi ancorate a Scapa Flow
A questo punto, per i marinai tedeschi in cattività inizia un periodo desolante: lontani dalle proprie famiglie e dalla patria, prigionieri su un arcipelago remoto e sferzato da venti gelidi, gli uomini si sentono demoralizzati, abbandonati a sé stessi e senza alcuna prospettiva. Il clima è infame, il cibo (che arriva dalla Germania un paio di volte al mese) è di scarsa qualità, la lentezza del servizio postale – unico legame con casa propria – è esasperante; oltre a ciò, tra gli equipaggi si creano spaccature interne dovute alle rivalità tra le varie fazioni politiche e la disciplina va peggiorando di giorno in giorno. Gli inglesi posti a guardia dei marinai tedeschi notano il divampare di frequenti risse e il comando britannico decide di stemperare la tensione con generose elargizioni di brandy, sigarette e tabacco, ma si tratta di un palliativo. I marinai, infatti, sono obbligati a restare a bordo delle proprie navi, non possono scendere a terra, né visitare gli altri equipaggi; solo gli ufficiali superiori hanno a disposizione un battellino inglese per portare gli ordini scritti da un’unità all’altra. Il tempo a bordo non sembra trascorrere mai: l’unico passatempo è la pesca, utile a rimpinguare le scorte in cambusa. Anche gli ufficiali hanno i loro guai: diversi marinai di fede socialista o comunista si sono consociati in gruppi di disturbo – tra cui la cosiddetta Guardia Rossa – che boicottano gli ordini e cercano di rendere loro la vita impossibile. Verso la fine di marzo, lo stesso contrammiraglio von Reuter deve trasferirsi dalla corazzata Friedrich der Grosse all’incrociatore leggero Emden, perché durante la notte alcuni marinai prendono a martellate le paratie al fine di impedirgli il sonno. Nel frattempo, gli inglesi iniziano a rimpatriare a scaglioni i marinai, che dai 20mila effettivi di novembre passano ai poco meno di 5000 nel mese di giugno.
Bisogna trovare un modo per lavare l'onta della deportazione della flotta
Gli alleati, intanto, non riescono a trovare un’accordo sul destino della “Hochseeflotte". Alla conferenza di pace di Parigi, Francia e Italia reclamano ciascuna un quarto della flotta, gli Stati Uniti sono indecisi e la Gran Bretagna si pronuncia a favore della completa distruzione, col recondito fine di non veder accresciuto il potere sui mari dei tre alleati. Quello che nessuno immagina, però, è che fin da gennaio molti ufficiali tedeschi hanno iniziato a pianificare un clamoroso gesto che restituisca almeno in parte l’onore alla flotta germanica; presagendo quali saranno gli umilianti termini del trattato di pace di Versailles, la cui ratifica è prevista a giugno inoltrato. Anche von Reuter sta meditando sull’opportunità di autoaffondare la flotta e inizia a preparare la complessa operazione di sabotaggio. La cosa non è semplice: occorre coordinare i movimenti di tutti gli equipaggi, eludere la sorveglianza degli inglesi – che intanto hanno cominciato a sospettare qualcosa – ed evitare possibili insubordinazioni. La fortuna, tuttavia, è dalla parte dei congiurati: sebbene si siano preparati a occupare le navi tedesche per evitare un colpo di mano, inspiegabilmente la mattina del 21 giugno gli inglesi al comando dell’ammiraglio Sydney Fremantle decidono di prendere il largo per un’esercitazione in alto mare. La giornata è radiosa, nessuno tra le fila britanniche potrebbe immaginare l’imminente catastrofe: alle 10 e 30 von Reuter, che ha indossato l’alta uniforme, ordina alle varie unità, tramite bandiere di segnalazione, di tenersi pronti all’azione. Il momento fatale scocca alle 11 e 20: «A tutti gli ufficiali comandanti e ai capitani delle torpediniere. Paragrafo 11 della data odierna. Confermato. Il Comandante in capo dello Squadrone internato».
In pochi minuti i tedeschi affondano le proprie navi. La dignità è salva
Mesi di umiliazione e vergogna vengono redenti in pochi minuti. Gli uomini agiscono con efficienza teutonica: le prese a mare e le valvole di inondazione vengono spalancate, le condutture interne distrutte. Alcuni uomini aprono e bloccano i portelloni interni, altri allentano gli oblò; su qualche nave, nei giorni precedenti, sono stati perfino praticati dei fori tra i vari compartimenti per accelerare l’ingresso dell’acqua. Per circa tre quarti d’ora non pare accadere nulla, poi la Friedrich der Grosse inizia a sbandare a dritta. Mentre cominciano ad affondare, tutte le unità innalzano il vessillo germanico sugli alberi maestri. Per il momento, gli unici e attoniti testimoni del suicidio di un’intera flotta da guerra sono alcuni giovani studenti britannici a bordo di un guscio di noce, che sono stati portati nella baia per poter vedere “gli Unni sconfitti». Le forze inglesi, in quel momento, dispongono soltanto di due cacciatorpediniere, sette pescherecci armati e poche altre piccole imbarcazioni: la confusione è enorme e l’ammiraglio Fremantle viene avvisato di quanto sta accadendo solo a mezzogiorno e mezzo, allorché dà ordine alla squadra navale di rientrare a Scapa Flow. Intanto, gli inglesi abbordano alcune unità e tentano di farle arenare, impedendo così il completo affondamento di 21 cacciatorpediniere. Quando Fremantle rientra nella rada, soltanto le unità di maggiore stazza sono ancora a galla, ma ormai c’è ben poco da fare; su sedici tra corazzate e incrociatori da battaglia, solo la SMS Baden si salva. Alle cinque del pomeriggio cola a picco anche l’Hindenburg: ben 54 unità sono affondate e l’onore della marina imperiale tedesca è salvo. Per gli inglesi si tratta di un affronto, un vero schiaffo morale; poiché hanno infranto i termini dell’armistizio, Fremantle dà ordine di considerare i marinai tedeschi come prigionieri di guerra e li fa deportare in un campo di prigionia in Scozia. Durante l’incontro con il contrammiraglio Ludwig von Reuter, Freemantle è assai duro e lo accusa di aver violato le regole della marineria e dell’onore; tuttavia, più tardi ammetterà di aver provato simpatia e rispetto per quell’antagonista che, trovatosi in una posizione terribile, aveva saputo conservare la sua dignità e quella della marina germanica. Le navi affondate inizialmente vennero lasciate sul posto, dato che l’abbondanza di materiali ferrosi alla fine del conflitto ne rendeva antieconomico il recu- pero; le autorità di Scapa Flow, tuttavia, lamentavano il fatto che i relitti costituissero un pericolo per la navigazione e nel 1923 cominciarono le operazioni di smantellamento. Nello stesso periodo si interessò al problema il noto imprenditore Alan Cox, che acquistò i relitti dall’Ammiragliato e quindi ne intraprese il recupero applicando tecniche innovative e utilizzando, per ironia della sorte, un vecchio bacino di carenaggio tedesco, preda bellica. L’ultima nave a essere smantellata, nel 1939, fu l’incrociatore da battaglia SMS Derfflinger: un’era si era chiusa definitivamente, ma all’orizzonte si prospettava il divampare di un nuovo, più terribile conflitto. Alcune unità (3 corazzate e 4 incrociatori), adagiatesi su fondali troppo profondi, non furono mai recuperate e oggi vengono visitate regolarmente da sub esperti, che hanno dato un nome tanto evocativo quanto tragico ai surreali resti della flotta affondata: il Valhalla sommerso.
Testo di Fabio Bourbon pubblicato sul numero 74 di Arte Navale. Su gentile concessione della rivista Arte Navale. Le immagini della Collezione privata George Matthews sono pubblicate su gentile concessione della rivista Arte Navale. E' fatto divieto per chiunque di riprodurre da mareonline.it qualsiasi immagine se non previa autorizzazione direttamente espressa dall'autore delle immagini al quale spettano tutte le facoltà accordate dalla legge sul diritto d'autore, quali i diritti di utilizzazione economica e quelli morali.
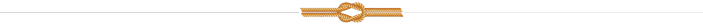
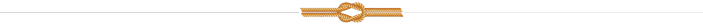




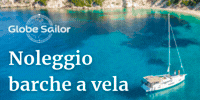






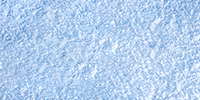








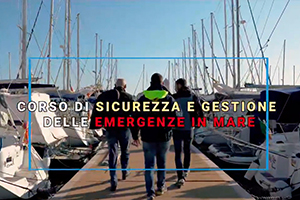
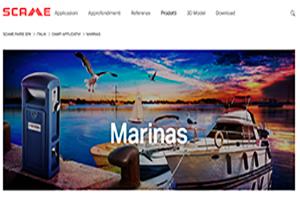












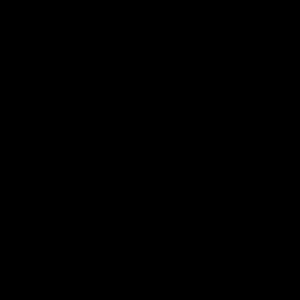

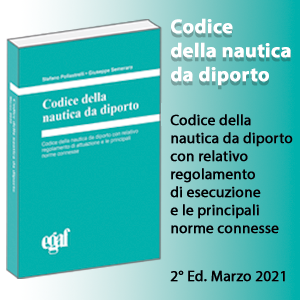

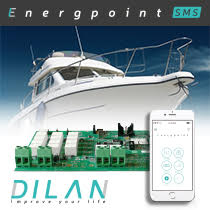
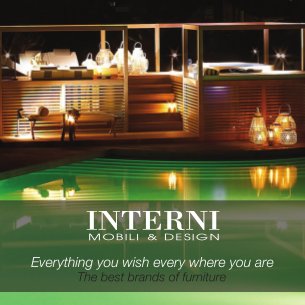

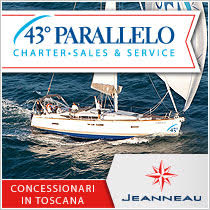


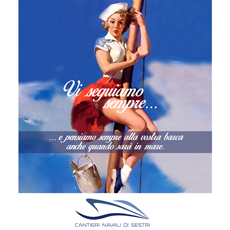






Egregi signori, mi chiamo Adrian Udroiu, ho 63 anni e sono un ingegnere metallurgico di nazionalità romena. Vivo e lavoro in Italia dal 1997, da 28 anni. Da quattro anni mi dedico alla stesura di un libro, "Il fantasma degli abissi", frutto della mia profonda passione per la meravigliosa macchina che è il sottomarino. Ho già completato due volumi e attualmente lavoro al terzo, che tratta la storia dei sottomarini durante la Grande Guerra. Nel mio intento, non desidero limitarmi all'inserimento di fotografie e tabelle, ma ritengo fondamentale contestualizzare i contenuti tecnici nell'ambito della situazione geopolitica dell'epoca, delle minacce belliche e delle motivazioni che hanno segnato il XX secolo. Fin dall'età di sei anni, nel 1968, quando imparai a leggere, la mia prima vera lettura fu un giornale di politica estera romeno. All'epoca, le notizie erano strettamente controllate dal Partito comunista romeno (PCR). Per illustrare la presunta "decadenza del mondo capitalista", questa pubblicazione, "Lumea" (Il Mondo), riferiva del disastro del secondo sottomarino nucleare perduto dagli Stati Uniti d'America, l'SSN Scorpion (mentre l'URSS, all'epoca, non aveva subito perdite, ma avrebbe successivamente colmato e superato tale divario).L'articolo della rivista menzionava una lettera indirizzata all'allora Presidente degli Stati Uniti, Lyndon B. Johnson. All'interno della busta era contenuto uno schizzo, disegnato da un bambino della mia età, figlio di un ufficiale imbarcato su un sottomarino a propulsione nucleare, presumibilmente immerso a una profondità di 3.000 metri (profondità alla quale lo schiacciamento dello scafo sarebbe stato inevitabile). Il 22 maggio 1968, un sottomarino d'attacco della classe Skipjack subì un'implosione, dopo aver superato la profondità di schiacciamento (500-600 m), inabissandosi. La Marina americana condusse diverse indagini sull'accaduto, senza tuttavia giungere a risultati conclusivi. Furono formulate diverse teorie al riguardo. L'incidente causò la morte di 99 ufficiali e marinai. L'USS Scorpion (SSN-589) fu dichiarato disperso il 2 giugno 1968, in una posizione situata 740 chilometri a sud-ovest delle isole Azzorre. Due settimane dopo, il 30 giugno 1968, il nome del sottomarino fu rimosso dai registri della Marina degli Stati Uniti. Ad oggi, il relitto del sottomarino giace ancora nella medesima posizione. Fui costretto ad accantonare la mia passione per i sottomarini fino al 1990, a causa della scarsità di letteratura specialistica e della mancanza di documentazione tecnico-scientifica trasmessa a livello televisivo. Tuttavia, dopo questo periodo di 22 anni, dal 1990, la mia passione si riaccese grazie alla crescente disponibilità di contenuti, sia cartacei che digitali, dedicati a questo argomento. Pur non essendo uno specialista del settore e non avendo mai navigato a bordo di un sottomarino, ho visitato numerosi musei navali in diverse parti del mondo, dove erano esposti sottomarini. Il mio libro si basa su informazioni provenienti da fonti rigorosamente citate nelle pagine della bibliografia. Inizialmente, avevo intenzione di consultare gli archivi della rivista "Lumea", ma ho dovuto rinunciare a tale proposito, non essendo riuscito a reperirli. Inoltre, non è mai stato reso noto se il Presidente Johnson abbia risposto alla lettera del bambino che aveva ipotizzato un sistema per salvare suo padre. Non sono nemmeno riuscito a trovare informazioni esaustive sull'USS Scorpion (SSN-589). Nonostante la delusione, la passione per il mondo sottomarino continua a essere per me motivo di grande soddisfazione anche adesso alla vecchiaia. Egregi signori, oggi, le fonti di informazione disponibili, in particolare attraverso Internet, consentono di accedere a un'ampia gamma di contenuti di interesse. Ho avuto modo di consultare il sito da Lei curato, trovandovi numerosi articoli di notevole interesse per la mia ricerca. Pertanto, Le chiedo cortesemente l'autorizzazione a inserire alcune informazioni tratte dal Suo sito nel terzo volume del mio libro, con debita citazione delle fonti. Se Lei acconsentisse, potrei inviarLe un prospetto dettagliato del materiale che desidererei includere, l'impaginazione prevista e, qualora Lei fosse interessato e avesse la disponibilità di tempo, i primi due volumi già pubblicati, nonché la bozza del terzo, in cui sono stati inseriti alcuni estratti dal Vostro sito. In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgo i miei più. Distinti saluti. Adrian Udroiu