






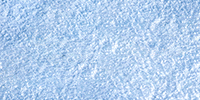











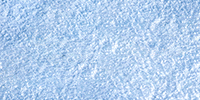





racconta l’ultima regata del grano

Dunkerque, una giornata grigia d’inizio primavera del 2005. Il vento fischia nelle sartie della Duchesse Anne che con il suo scafo bianco e i suoi alberi maestosi ondeggia come volesse liberarsi delle catene e riprendere il largo. Sono sulla banchina antistante il Musée Portuaire ad attendere l’arrivo di Eric Newby dall’Inghilterra. Le sue fotografie sono appena entrate a far parte della collezione del museo ed è una gioia incontrarlo nuovamente per parlare dil suo incredibile viaggio e del libro The Last Grain Race. “A Londra, nel 1938, ho lasciato il mio lavoro presso Wurtzel (un’agenzia pubblicitaria) per imbarcarmi come mozzo sul Moshulu, un veliero finlandese di 5.300 tonnellate di stazza lorda che faceva il viaggio verso l’Australia per imbarcare grano e portarlo in Europa. Non sapevo nulla di quella nave sino al giorno in cui ci sono salito a bordo… a Belfast. Ma non sapevo neppure che quel viaggio sarebbe stato l’ultima regata del grano”. A 86 anni, lo scrittore inglese amava ancora parlare dei velieri ed è stata per me una grande emozione raccogliere la sua testimonianza prima della sua scomparsa nell’autunno 2006.
Gli inglesi sono stati i primi ad abbandonare la vela per passare a navi a vapore
Alla fine della prima guerra mondiale, il quadro economico internazionale non era più lo stesso degli anni precedenti e il mondo marittimo era di conseguenza profondamente cambiato. Il vapore si era imposto su tutte le linee. Gli inglesi per primi avevano lasciato la vela per passare a navi più veloci e sicure. Le condizioni affinché la navigazione commerciale a vela continuasse a vivere sembravano non esistere più. Le più grandi compagnie armatrici di velieri, i francesi Bordes di Bordeaux e i tedeschi Laeisz di Amburgo, avevano perduto in seguito alla guerra buona parte delle unità della loro flotta di Cape Horners. La Germania aveva perso il conflitto e la compagnia Laeisz vide disperdersi le unità restanti della sua famosa flotta Flying-P Line, date a molti Paesi come riparazione di guerra. La mancanza di carichi interessanti, i prezzi delle assicurazioni saliti alle stelle, gli equipaggi qualificati ormai diventati rarissimi (una generazione intera di giovani era stata divorata dalla guerra) e la giornata lavorativa di otto ore che obbligava ad avere tre turni di guardia, segnarono il punto di non ritorno. Le grandi flotte vennero disarmate: le unità migliori furono vendute al prezzo della ferraglia, le altre mandate alla demolizione.
Solo sulle rotte dall’emisfero sud verso l’Europa i velieri continuavano a essere competitivi
Nonostante ciò alcuni Paesi continuavano a richiedere ai propri marinai la pratica nelle unità a vela per diventare ufficiali ed esisteva inoltre una nicchia di mercato assai precisa, quella del trasporto del grano dall’emisfero sud verso l’Europa, in cui i velieri, sfruttando i trade winds, potevano ancora competere in velocità ed economia di trasporto con il vapore o le emergenti navi con motore diesel. Questo panorama fu proficuo per pochi abili armatori nord europei. Gustaf Erikson, originario delle isole Åland in Finlan-dia, a seguito di riuscite speculazioni sui trasporti marittimi riuscì ad acquistare le unità più prestigiose ancora esistenti. Non solo fece riparare e armò nuovamente i velieri, ma lo fece così bene che tutte le sue navi erano quotate 100 A1, il massimo valore, presso il registro del Lloyd in quasi tutti i Paesi. Il suo principale segreto fu un grande e vero amore per la vela, una profonda conoscenza del mestiere e un senso degli affari molto sviluppato. Erikson veniva da una famiglia di armatori e aveva cominciato la sua carriera all’età di nove anni come steward; divenne poi cuoco di bordo, ufficiale e infine a 20 anni, terminati gli studi, ottenne il suo primo comando. Solo dopo 10 anni di navigazione sui velieri abbandonò il ponte di comando per dedicarsi interamente all’attività di armatore. “Sulla nostra nave”, racconta Newby, “lo chiamavamo Ploddy Gustav (deformazione scherzosa dell’espressione Bloody Gustav, diabolico Gustav. Così modificato il termine è inteso come Gustav lo sgobbone), sebbene nessuno di noi lo avesse mai visto. Ciò che lo rendeva simpatico ai nostri occhi era la certezza che egli se ne infischiasse di essere amato o no dai suoi equipaggi. Quello che gli interessava era che i marinai avessero cibo a sufficienza (secondo le norme della marina dell’epoca) e non mancassero di nulla per far funzio- nare i suoi velieri. Certamente la sapeva lunga in fatto di navi”.
Il viaggio verso l’Australia e ritorno era una traversata senza scalo di 260 giorni
Il viaggio verso l’Australia e ritorno durava quasi un anno, era cioè una traversata senza scalo di 260 giorni. In generale le navi partivano dal Nord Europa, attra- versavano l’Atlantico andando verso sud, a cercare i venti favorevoli e costanti, pas-savano Capo di Buona Speranza e, dopo aver percorso 15mila miglia marine in tre o quattro mesi, arrivavano a destinazione nel Golfo di Spencer nel periodo di Natale. Questa parte del viaggio molto spesso veniva fatta “in ballast”, cioè con la stiva riempita di zavorra. Il veliero tipico del trasporto del grano era il Cape Horner: scafo in acciaio, 4.300 tonnellate di stazza lorda, quattro alberi e 3.500 metri quadrati di vela, un equipaggio di 30 marinai compresi ufficiali e comandante. Raggiungere l’Australia non era facile. All’altezza dei famosi roaring forties il mare era terribile e un equipaggio così ridotto doveva compiere miracoli di coraggio e forza. Dopo un mese passato nel mare in tempesta nessun indumento era asciutto, stare al timone nelle lunghe notti d’inverno era una tortura così come erano massacranti le continue manovre per orientare verghe e vele pesanti alcune tonnellate: tutte le manovre erano realizzate a forza di braccia. Come racconta Newby, “Più il tempo passava, più la nave occupava i nostri pensieri. Le nostre vite le erano dedicate. Cento volte al giorno i nostri occhi andavano verso quel magnifico castello di tela sopra la nostra testa, la bella e profonda curva delle vele alte, la tensione dei cavi delle vele basse; ascoltavamo il respiro grave del vento nelle alte verghe, le trepidazioni e i rumori sordi del timone mentre la nave faceva rotta con potenza; ascoltavamo il timoniere suonare la campana del turno o segnalare l’ora del pranzo. Il ritmo con il quale vivevamo finiva per farci dimenticare la realtà del mondo esterno. Quando ci gettavamo nelle cuccette, completamente vestiti e bagnati, sentivamo il ruggire del vento e il passo dell’ufficiale di turno sul ponte, sapevamo che saremmo stati chiamati alla manovra ben presto. Non avevamo neppure fretta di arrivare: ci aspettava un Paese straniero, un posto isolato dove eravamo senza un soldo. Era molto difficile pensare al futuro serenamente, così ci rifugiavamo nel presente”. Finalmente raggiunto il porto di destinazione, principalmente Port Lincoln o Port Victoria, venivano scaricate le 2mila tonnellate di zavorra, si preparava la stiva ed erano caricati i circa 60mila sacchi di grano di circa 75 chilogrammi l’uno.
Caricare male i 60mila sacchi di grano poteva significare far affondare la nave
Anche questo lavoro richiedeva forza e impegno ma soprattutto una grande perizia nello stivare i sacchi: il loro smottamento durante la navigazione, sotto la formidabile spinta delle onde durante una tempesta, era molto spesso causa della perdita della nave, del carico e dell’equipaggio intero. Circa tre mesi dopo l’arrivo in Australia, la nave era pronta per ripartire verso l’Europa con i suoi preziosi sacchi accuratamente stivati. “Per due notti e un giorno, il Moshulu restò in rada, carico e pronto a partire; il vento era instabile e poco costante. Sabato 11 marzo 1939 il vento arrivò. Molti rumori da tanto tempo dimenticati tornarono: le grida dell’equipaggio che bordava un fiocco, il rumore dell’ancora che veniva salpata… La maggior parte di noi era felice di partire, di abbandonare la sporcizia del porto e le sordide condizioni di vita a terra. La nave ricominciava a vivere”.
Nelle regate del grano i distacchi erano abissali. Il più veloce la concluse in 83 giorni, il più lento in 163
Di regola un viaggio che dal Golfo di Spencer all’Europa durava 100 giorni era con- siderato un “passaggio” veloce. Nel 1928 l’inglese International Paint Company mise in palio la magnifica coppa d’argento che divenne il simbolo delle Grain Races. Fu vinta dalla Herzogin Cecilie, veliero preferito e ammiraglia della flotta di Erikson. Nel 1933 la nave a palo finlandese Parma effettuò la traversata più veloce in 83 giorni. La più lenta fu quella del Winterhude in 163. Sebbene in Inghilterra, Scandinavia e Germania le scommesse fossero alte e l’attenzione popolare forte, non si può parlare di vere e proprie competizioni organizzate. Se per le “regate del the” il tempo era un reale fattore economico tale da giustificare la corsa (per evitare la perdita di freschezza del prodotto), la quintessenza delle regate del grano era piuttosto lo spirito marinaro degli equipaggi e del comandante che volevano dimostrare a se stessi e agli altri il proprio valore e quello della nave. Dall’Australia verso il Sud America, scendendo verso gli howling fifties, con vento e correnti in poppa nella direzione di Capo Horn, i velieri a pieno carico viaggiavano a 14, 15 nodi di velocità inalberando tutte le vele che la nave poteva spiegare. Così Eric Newby ricorda il passaggio di Horn: “La nave correva sulle onde che si erano formate nelle immensità oceaniche e che avevano acquisito una potenza e una mole senza eguali poiché nulla, nel loro pazzo giro del mondo, le fermava. Dinnanzi una tale forza del mare, il veliero sembrava un giocattolo…”. “…Salii sull’albero di mezzana. A 59 metri dal ponte il vento soffiava a più di 120 chilometri all’ora e il rumore era impressionante. In basso, lontano sotto di me, la nave scompariva sotto le onde verdi e risorgeva dalle acque come farebbe un animale per liberarsi dell’attacco di una muta di cani in corsa”. Malgrado le condizioni limite di una simile navigazione lo spirito dell’equipaggio era alto e la competizione infervorava gli animi. “Alla nostra destra, il Passat (un altro veliero in regata) era magnifico a vedersi. Chiesi: “Possono batterci?”. “Nessuno può batterci!”, fu la risposta. “Se il capitano darà alla nave tutta la vela che lei vuole nessuno può superarci”. A bordo del Moshulu avevamo tutti la stessa idea: vincere la regata. Verso sera il Passat era stato lasciato indietro, fuori dalla nostra vista”.
I principali nemici? Le tempeste a Capo Horn, il Pampero, le calme equatoriali, i vapori…
Ma Horn non era il solo pericolo. Risalendo l’Atlantico verso nord il Pampero, vento caldo argentino, improvviso e violento, era assai temuto. Poi si dovevano evitare le calme equatoriali e in seguito fare molta attenzione ai vapori che attraversavano l’oceano verso l’Europa o l’America. Molti velieri vennero speronati e affondati nel Nord Atlantico o nella Manica proprio quando il viaggio era quasi finito. “Per la prima volta dopo mesi di navigazione potevamo sentire l’odore della terra, un misto di odor di faggeta dopo la pioggia o di felci all’alba, di ginestra sulle colline. Queenstown e le colline irlandesi erano in vista a poche miglia”. La corsa del ’39 vide arrivare primo il Moshulu con 91 giorni di traversata dall’Australia all’Inghilterra, secondo il Padua con 93, terzo il Pamir con 96. Se la traversata non era stata molto veloce, dopo aver scaricato il carico e cambiato l’equipaggio la nave partiva per un altro viaggio come il precedente. Con una buona media c’era invece tempo per tornare a casa nel Baltico per l’estate, prima di ripartire in autunno. Dopo la seconda guerra mondiale ben poco rimaneva di quel mondo e poche erano le navi sopravvissute. Solo due velieri Cape Horner, il Kruzenstern, ex Padua, e il Sedov, ex Kommodore Johnsen, ultimi esemplari di una razza estinta, hanno ripercorso quelle rotte recentemente ma in un viaggio commemorativo e con a bordo i cadetti della marina mercantile russa. Newby vide giusto quando scrisse: “Oggi non esistono più velieri sulle rotte mercantili. Se mai altri dovessero essere armati un giorno, sarebbero tanto diversi dal Moshulu quanto i loro equipaggi lo sarebbero dai miei compagni di viaggio”.
Testo di Jacopo Brancati, pubblicato sul numero 45 di Arte Navale. Su gentile concessione della rivista Arte Navale. Le immagini di Eric Newby sono pubblicate su gentile concessione della rivista Arte Navale. È fatto divieto per chiunque di riprodurre da mareonline.it qualsiasi immagine se non previa autorizzazione direttamente espressa dall’autore delle immagini al quale spettano tutte le facoltà accordate dalla legge sul diritto d’autore, quali i diritti di utilizzazione economica e quelli morali.
pubblicato il 19 Ottobre 2020 da admin | in Storie | tag: Cape Horners, Duchesse Anne, Eric Newby, Flying-P Line, Grain Races, Gustaf Erikson, Herzogin Cecilie, isole Åland, Jacopo Brancati, Moshulu, Musée Portuaire, The Last Grain Race | commenti: 1

Just Peruzzi, "Il ristorante panoramico più bello d’Italia" - Corriere della SeraVi aspettiamo per accogliervi in quello che il Corriere della Sera ha definito come "Il ristorante panoramico più bello d’Italia"
Pubblicato da Just Peruzzi su Martedì 30 aprile 2024
 I grandi chef vi "servono" le loro ricette
Ristoranti al mare
I grandi chef vi "servono" le loro ricette
Ristoranti al mare
 Le rotte per i ristoranti d'autore
Voglia di crociera
Le rotte per i ristoranti d'autore
Voglia di crociera
 Splendida la nave, splendide la mete
Navigate con la Fantasia negli Emirati
Con Msc Seaside fino in America
Le migliori vacanze in barca
Splendida la nave, splendide la mete
Navigate con la Fantasia negli Emirati
Con Msc Seaside fino in America
Le migliori vacanze in barca
 Segnalateci la vostra proposta
Case al mare
Segnalateci la vostra proposta
Case al mare
 V'indichiamo la rotta giusta
V'indichiamo la rotta giustain un mare d'investimenti Rotte nell'entroterra
 Segnalateci la vostra proposta
"Navigate" tra le sagre
Segnalateci la vostra proposta
"Navigate" tra le sagre
 Nei borghi i pescatori cucinano per voi
Accessori & partner
Nei borghi i pescatori cucinano per voi
Accessori & partner
 Come e dove rendere la barca unica
Approdi d'autore
Come e dove rendere la barca unica
Approdi d'autore
 Le rotte nei più affascinanti hotel sul mare
Antiquariato & collezionismo
Le rotte nei più affascinanti hotel sul mare
Antiquariato & collezionismo
 Dove navigare fra aste, negozi...
Associazioni di mare
Dove navigare fra aste, negozi...
Associazioni di mare
 Ecco chi tramanda storie e tradizioni
Cantieri e maestri d'ascia
Ecco chi tramanda storie e tradizioni
Cantieri e maestri d'ascia
 Qui gli scafi tornano a splendere
I vostri annunci
Qui gli scafi tornano a splendere
I vostri annunci
 Vendete barche, posti barca, oggetti…
Corsi e patenti nautiche
Vendete barche, posti barca, oggetti…
Corsi e patenti nautiche
 Le migliori scuole per imparare
Le migliori scuole per imparareClick sull'acqua
 Le più belle foto di mare.
Mare by night
Le più belle foto di mare.
Mare by night
 I locali più trend dove approdare
Diving center
I locali più trend dove approdare
Diving center
 Immergersi fra fondali da sogno e relitti
Navighiamo nei musei
Immergersi fra fondali da sogno e relitti
Navighiamo nei musei
 Qui si racconta la storia della navigazione
Presi all'amo
Qui si racconta la storia della navigazione
Presi all'amo
 Bravi pescatori si nasce o si diventa?
Porti turistici
Bravi pescatori si nasce o si diventa?
Porti turistici
 I migliori marina del Belpaese
Lavori in mare
I migliori marina del Belpaese
Lavori in mare
 Come e dove trovare un impiego
Un mare di shopping
Come e dove trovare un impiego
Un mare di shopping
 Abiti, accessori, gioielli e orologi...
Storie e personaggi
Abiti, accessori, gioielli e orologi...
Storie e personaggi
 Per chi naviga con la fantasia
Traghetti ed imbarchi
Per chi naviga con la fantasia
Traghetti ed imbarchi
 Cosa sapere su rotte ed offerte...
Cosa sapere su rotte ed offerte...






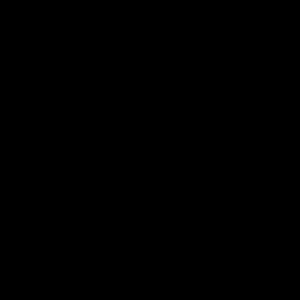











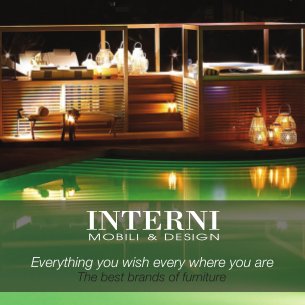




PRONTO SOCCORSO IN MARE
 Sono diversi i possibili problemi di salute che possono subentrare in mare, durante la navigazione,
spesso legati proprio alla vita di mare: da una banale caduta a un tuffo sbagliato, da una puntura di
riccio a una bruciatura di medusa, a un'otite, un'insolazione…
Sono diversi i possibili problemi di salute che possono subentrare in mare, durante la navigazione,
spesso legati proprio alla vita di mare: da una banale caduta a un tuffo sbagliato, da una puntura di
riccio a una bruciatura di medusa, a un'otite, un'insolazione…Cliccate qui per rivolgervi direttamente al medico di mareoline… IL MARE IN TAVOLA
 Mareonline vi invita a scoprire i migliori cibi e vini (ma anche liquori e sigari) da gustare in barca,
indicandovi la rotta per raggiungere i migliori prodotti del mare:
Cibi e Vini
RICETTE DI MARE
Mareonline vi invita a scoprire i migliori cibi e vini (ma anche liquori e sigari) da gustare in barca,
indicandovi la rotta per raggiungere i migliori prodotti del mare:
Cibi e Vini
RICETTE DI MARE
 Mareonline vi propone alcune ricette per cucinare, a casa o in barca, piatti a base di pesce e crostacei.
Mareonline vi propone alcune ricette per cucinare, a casa o in barca, piatti a base di pesce e crostacei.Cliccate qui per scoprire ingredienti e preparazione... SBARCO AL RISTORANTE
 Mareonline vi invita a scoprire i migliori ristoranti lungo le coste del Belpaese, raggiungibili direttamente in barca.
Mareonline vi invita a scoprire i migliori ristoranti lungo le coste del Belpaese, raggiungibili direttamente in barca.Cliccate qui per trovare il vostro ristorante
Cliccate qui per leggere i ristoranti segnalati da voi. MODA E ACCESSORI
 Cliccate qui per scoprire che look deve esibire un vero lupo di mare anche in terraferma...
LE FOTO PIU' CURIOSE
Cliccate qui per scoprire che look deve esibire un vero lupo di mare anche in terraferma...
LE FOTO PIU' CURIOSE"PESCATE" SU FACEBOOK
 Segnalateci le foto più curiose che avete "pescato" su facebook (inviando una e mail a
mareonline@mareonline.it
o lasciando un messaggio sulla sulla pagina facebook di mareonline)
IL ROMANZO
Segnalateci le foto più curiose che avete "pescato" su facebook (inviando una e mail a
mareonline@mareonline.it
o lasciando un messaggio sulla sulla pagina facebook di mareonline)
IL ROMANZO
 cliccate qui per leggere il romanzo il vento e la farfalla di Franco Fabretti
SIAMO TUTTI FOTOGRAFI
cliccate qui per leggere il romanzo il vento e la farfalla di Franco Fabretti
SIAMO TUTTI FOTOGRAFI
 Avete degli "scatti" particolari fatti al mare, in navigazione?
Avete degli "scatti" particolari fatti al mare, in navigazione?Inviateli a mareonline@mareonline.it con vostro nome cognome località fotografata.
Le migliori potrebbero apparire in Home page… Cliccate qui




















Ottimo articolo, poche le foto…