






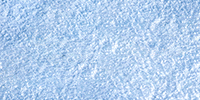











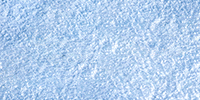





italiani entrati nella leggenda
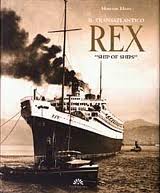
Mater sempre certa est, dicevano i latini, lasciando intendere che per il padre potevano sussistere dei dubbi. Non fu così per i transatlantici moderni, la cui paternità è indubitabilmente attribuita a Isambard Kingdom Brunel, un geniale ingegnere inglese con il pallino per il ferro e la meccanica che qualcuno ha paragonato a un Leonardo da Vinci del XIX secolo, con il solo difetto di essere in anticipo sui tempi di almeno mezzo secolo. Brunel aveva già inventato tutto, dai ponti con arcate uniche fino a due chilometri, alla avveniristica “ferrovia atmosferica”, quando i dirigenti della Great western railway si lamentarono con lui sulla limitatezza della loro rete ferroviaria. Brunel, intuendo le grandi prospettive offerte dal vapore, di cui la Gwr era certamente esperta, osservò impassibile che non sarebbe stato poi così difficile allungarla, perché no, fino a New York. Il direttore borbottò scettico “Questo sta già pensando di mandarci sulla luna”. In effetti, nel 1859 Brunel lanciò sul Nordatlantico il suo capolavoro, il Great Eastern, con una stazza di ben 18.000 tonnellate e con l’incredibile capacità di trasporto di 4mila passeggeri, più di quanti ne trasporta oggi una super nave da crociera. Ma l’esordio fu disastroso. Una furiosa tempesta costrinse l’immenso transatlantico a rientrare in porto poco dopo la partenza: “L’enorme massa, lentamente incominciò ad oscillare, facendo sparire le signore nelle viscere della nave. Il vallo dell’onda crebbe, mentre all’orizzonte si levava la tempesta e a coricarsi su un fianco…
La nuova era? È salpata sul Great Eastern, capace di trasportare, nel 1859, 4mila passeggeri…
All’interno, le belle sale poco prima risplendenti sembravano un campo di battaglia; i resti sanguinolenti di una mucca caduta abbasso dalla coperta si mescolavano ai mobili in frantumi e alle schegge di vetro.” (B. Tavernier – Le grandi vie marittime). Il Great Eastern concluse malinconicamente la sua carriera come nave posacavi. La grande avventura della ville flottante, come la definì Giulio Verne, che alla nave dedicò un romanzo, sembrava finita: in realtà era appena incominciata. Il 1881, sull’onda della raggiunta unità del Paese, la marineria italiana aveva celebrato la prima grande ristrutturazione della flotta nazionale, riunendo, in un’unica società, la Navigazione generale italiana, i padri fondatori dell’armamento italiano: il genovese Raffaele Rubattino e i siciliani Florio. Sull’altare della ragion di Stato, i due antichi competitori si presentarono al tavolo della resa reagendo ciascuno a modo suo: Rubattino si piegò piangendo “alla suprema conquista e insieme alla suprema rinuncia”; ne morì di dolore l’anno dopo. I Florio, invece, pare che commissionassero per l’occasione un modellino di nave in oro massiccio a dimostrazione della loro potenza e della loro grandezza. Ma nonostante una flotta di quasi 100 navi e le successive incorporazioni di Società minori, la Navigazione generale continuò per molti decenni a mantenere un basso profilo, stretta fra vincoli finanziari imposti dal principale azionista, la neonata Banca commerciale italiana (che, a dispetto della denominazione, era controllata da capitali tedeschi) e l’incapacità di spiccare il volo e di affrontare la sfida ad armi pari con i competitori germanici, francesi e inglesi.
… ed è cresciuta sulla scia di milioni di emigranti italiani diretti in America
Fu necessario attendere il 1910 per registrare un cambiamento radicale nella strategia della Ngi che, dopo 40 anni di assenza del tricolore dai moli di New York, si decise a scendere in campo nell’ambito mercato delle traversate oceaniche verso il Nordamerica creato e sostenuto da quell’epico esodo di milioni di italiani che era stato, fino ad allora, appannaggio quasi esclusivo degli armamenti europei. Alla vigilia della Prima guerra mondiale, l’intera flotta nazionale passeggeri poteva contare su 36 navi per una stazza complessiva di poco superiore alle 200.000 tonnellate.
All’inizio la flotta italiana arrancava a 14 nodi mentre l’Inghilterra volava sulle onde col Mauretania a 26…
Una flotta che, nella media generale, solcava le onde ad una velocità non superiore a 14 nodi e le cui navi più grandi, come il Campania, il Lazio e il Sannio, sfioravano le 9mila tonnellate: i tedeschi avevano da tempo varato la Kaiser Wilhelm der Grosse da 24mila tonnellate e gli inglesi, con il Mauretania, già da 10 anni superavano se stessi volando sull’oceano a quasi 26 nodi alla ripetuta conquista del Nastro Azzurro.
… ma la nascita delle navi gemelle ha segnato l’inizio della rivincita
A ben vedere, si può dire che la storia del riscatto della marineria italiana nella grande competizione transatlantica si identifichi con quella di navi gemelle o quasi. Una specialità tutta nostrana, una sorta di albero genealogico che, intrecciandosi con i complessi sviluppi dinastici delle società armatrici, ha realizzato parentele feconde e incroci di razza. È forse proprio la storia di navi gemelle, che ha ben pochi riscontri a livello mondiale, che prima ha portato il tricolore a sventolare sui mari con dignitoso orgoglio, poi lo ha sostenuto sino al trionfo e all’ammirazione incantata del mondo e, infine, lo ha accompagnato nel suo declino fino alla sua scomparsa.
Giulio Cesare e Duilio, Roma e Augustus: ecco le navi che hanno tracciato la rotta vincente
Giulio Cesare e Duilio, i capostipiti, lasciarono il posto al Roma e all’Augustus, seguiti dal Rex e dal Conte di Savoia. Gli ultimi sfortunati gemelli della marineria italiana, Michelangelo e Raffaello, possono considerarsi a tutti gli effetti gli eredi diretti dell’Andrea Doria e del Cristoforo Colombo. Il Giulio Cesare e il Duilio, i primi veri transatlantici della marineria italiana, ebbero un avvio faticoso e contraddittorio. Pensati per competere alla grande nella sfida transatlantica, furono concepiti ancora una volta per i servizi verso il Sudamerica, l’unica rotta conosciuta dall’armamento nazionale, quella dove si era concentrata nei decenni precedenti la prima grande ondata migratoria delle nostre popolazioni del Nord Italia. Le commesse furono assegnate nel 1915 al cantiere inglese Swan Hunter e all’Ansaldo di Sestri Ponente, ma solo il Duilio poté essere varato l’anno successivo. Lo scoppio del conflitto bellico bloccò sugli scali inglesi il Giulio Cesare, che ricevette il battesimo dell’acqua solo nel 1920. Quando entrarono in servizio erano passati oltre otto anni dal loro concepimento e tante cose erano cambiate. Fra tutte, la loro destinazione commerciale: la Ngi si era finalmente accorta del fiume impetuoso di emigranti italiani diretti verso gli Usa, meta colpevolmente ignorata per troppi decenni. E in quella direzione le due navi furono dirottate, rendendo, fra l’altro, superfluo il costoso e avveniristico sistema thermotanks, una sorta di meccanismo per l’aria condizionata di cui i due gemelli erano stati dotati per affrontare le torride traversate verso i mari sudamericani.
Studiando la “sella d’onda” fu possibile attraversare l’Atlantico da Genova a New York in meno di 9 giorni
Ma se la partenza fu in salita, il Giulio Cesare e il Duilio si rivelarono presto due campioni di razza. Tutto era stato ripensato per dare un taglio netto con i compromessi del passato e poter affrontare la sfida attraverso l’Atlantico a testa alta. Intanto, le dimensioni: 24.400 tonnellate per quasi 200 metri di lunghezza. La velocità era superiore a 20 nodi e consentiva di coprire la distanza tra Genova e New York in 8 giorni e 20 ore. Entrambi furono progettati dal grande architetto navale Garelli, che insieme a tanti altri (primo fra tutti il giovanissimo triestino Costanzi, geniale studioso della “sella d’onda”) furono gli artefici del successo della nostra cantieristica, inaugurando una scuola invidiata e imitata in tutto il mondo. La prima classe – di lusso – era disposta su sei ponti per un totale di 257 posti: nessuna cabina interna, nessun letto sovrapposto, sala per esercizi fisici, ponte passeggiata, salone da pranzo, grande salone delle feste, sale di scrittura e di lettura, sale per bambini. Anche la seconda e la terza classe erano state rivoluzionate, con ampi spazi comuni e cabine separate. Gli interni erano spettacolari, ricchi di stucchi, decorazioni e arredamenti strepitosi che avrebbero fatto scuola nel mondo intero. Fonti giornalistiche dell’epoca così descrivono, per esempio, il vestibolo: “Completamente in quercia stile Luigi XVI, di 18 metri per 13, con un’altezza al centro di 7 metri e alle pareti preziosi arazzi di disegno italiano, con una parete occupata da una grande fontana marmorea, con un’abbondanza di splendidi mobili, esempio di inarrivabile eleganza e bellezza”. Il cronista del Corriere Mercantile a bordo del Giulio Cesare nel 1922 osservava estasiato: “Visitare la classe di lusso è una cosa piacevolissima ma si rimane perplessi dinanzi all’ampiezza e allo sfarzo, ampiezza che costa tesori, se si riflette che si è su un bastimento, sfarzo che in via assoluta raggiunge e supera quello di qualsiasi principesco palazzo”. E concludeva domandandosi perché “la stessa Navigazione generale abbia potuto tanto discutere sull’opportunità del lusso: i viaggiatori lo vogliono e amano pagarlo”. Il Giulio Cesare e il Duilio, che erano costati 100 milioni di lire ciascuno, ebbero un grande successo sulla linea nordamericana sino al 1927, quando vennero sostituiti dal Roma e dall’Augustus e poterono finalmente servire la rotta verso il Plata per la quale erano stati pensati e costruiti.
Con gli scafi dipinti di bianco iniziò l’era delle crociere in alto mare…
Passati al Lloyd Triestino, dopo i lavori del 1932, videro il loro scafo dipinto di bianco: era iniziata la grande stagione delle navi bianche, sinonimo di freschezza e spensierata vacanza, geniale intuizione evocativa della crociera in alto mare. Quasi contemporaneamente era stata varata un’altra coppia di gemelli, frutto di un ramo parallelo della grande famiglia dell’armamento italiano.
… mentre il verde e il rosso furono i colori della favolosa serie dei Conti
Il Lloyd Sabaudo aveva dato l’avvio alla “favolosa serie dei Conti” affidando la costruzione del Conte Verde e del Conte Rosso a cantieri scozzesi. Il Conte Rosso, trattenuto come il Giulio Cesare, sugli scali inglesi a causa dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, fu acquistato dalla Royal Navy, ribattezzato Argus e trasformato in portaerei, la prima portaerei del mondo a ponte continuo. Ma i problemi erano davvero tanti per far atterrare e decollare i fragili biplani del 1917 dal ponte di una nave concepita per il trasporto dei passeggeri. Allo scopo di attutire l’impatto degli aerei con il ponte di coperta si pensò di ricoprirlo di terra, realizzando un bel prato verde innaffiato regolarmente da un plotone di addetti. Ma alla fine, l’idea non ebbe grande successo. Trent’anni dopo, all’inizio della Seconda Guerra Mondiale, a un’altra nave passeggeri italiana toccò le triste sorte di trasformarsi in portaerei, questa volta, senza giardinieri: le foto ingiallite del Roma ingiuriosamente decapitato nei ponti superiori e dall’aspetto di un’enorme, insulsa vasca da bagno, testimoniano il dramma e, insieme, la disperazione di quel momento. I due Conti non erano navi molto grandi, ma eccellevano per l’eleganza e la raffinatezza degli interni firmati da Coppedé.
La risposta italiana all’art nouveau inaugurata dall’Ile de France vinse la sfida in Sudamerica
Era la risposta italiana all’art nouveau inaugurata dall’Ile de France, anche se erano ancora forti le tentazioni che tenevano ancorati gli architetti italiani allo sfarzo barocco dei saloni, agli stucchi dorati, all’orgia decorativa che trovarono nel Roma e nell’Augustus la loro consacrazione finale. I due Conti conquistarono fama leggendaria sulle rotte del Sudamerica per l’eleganza, la comodità, la regolarità del servizio fino a quando, nel 1932 il Governo italiano decise le seconda grande rivoluzione della marineria nazionale, fondendo fra di loro i due storici rivali, la Ngi e il glorioso Lloyd Sabaudo, dando così vita alla società Italia. Nella ripartizione generale del naviglio, i due gemelli si troveranno uniti sotto la bandiera del Lloyd Triestino che li indirizzò sulle rotte dell’Estremo Oriente. Lo scafo, naturalmente, fu ridipinto di bianco secondo le regole della casa. La storia del Conte Verde è molto lunga e, sotto certi profili, si può dire che non si sia ancora conclusa. Allo scoppio della Seconda guerra mondiale, la nave fu sorpresa nelle acque di Shanghai e, come accaduto per tanti altri piroscafi italiani, l’equipaggio assunse l’amara e suprema decisione di autoaffondarsi. Ma i giapponesi riuscirono qualche tempo dopo a recuperare l’imbarcazione, a rimetterla in sesto e, con un altro nome, a utilizzarla per i propri traffici. Alla fine del conflitto furono sottoscritti numerosi e complessi accordi per l’indennizzo dei danni subiti in guerra, ma pochi se ne accorsero o furono così diligenti da andarseli a studiare. Cinquant’anni dopo la fine della guerra il Lloyd Triestino era ormai prossimo al collasso. Finanziariamente parlando, nell’autunno del 1997, al glorioso Lloyd Triestino, la più antica Compagnia di navigazione del mondo, restavano ancora forse due o tre mesi di vita. Il momento era davvero disperato ma a qualcuno, superando le facili ironie su una proposta che sembrava uno scherzo, venne in mente il danno subìto dalla Società, più di 50 anni prima, con la perdita del Conte Verde. Anche la burocrazia ha un cuore e quella volta seppe dimostrarlo con grande efficienza: i 19 miliardi di lire riconosciuti e accreditati tempestivamente sul conto della Società, ormai agonizzante, consentirono al Lloyd di riprendere fiato e di essere dignitosamente ceduto alla Evergreen. Ma torniamo alla seconda generazione dei gemelli italiani, quella del Roma e dell’Augustus. Si trattava di veri giganti: furono i primi colossi del mare nazionali a superare le 30mila tonnellate e i 200 metri di lunghezza, misure inusitate per il cantiere Ansaldo di Sestri al punto che lo specchio acqueo dovette essere dragato per favorire il varo delle navi.
Prime al traguardo, le navi italiane faticavano a… partire. Il varo del Roma durò oltre 24 ore
E a proposito di vari, il Roma fu protagonista, un mattino di febbraio del 1926, di una resistenza senza precedenti nel lasciare lo scalo del cantiere. Davanti a una platea di invitati, eccezionale per numero e per lustro, la grande nave rimase infatti aggrappata ben 24 ore al sego dello scivolo indurito dal freddo. Maurizio Eliseo così riporta la cronaca dell’imbarazzante cerimonia: “I cronisti del tempo cercarono di convincere i lettori che era una cosa normale convocare autorità e decine di migliaia di persone alle 14, benedire la nave alle 15, lanciarle sulla fiancata una bottiglia di spumante alle 17, tornare il mattino dopo di buon ora e aspettare fino a metà pomeriggio per vedere la nave scendere in acqua”. Una volta tanto il regime, che non tollerava la più piccola smagliatura organizzativa, la prese sul ridere e Costanzo Ciano si fece fotografare mentre simulava di spingere la nave invitando le altre autorità a seguire il suo esempio.
… e anche il Rex rimase inchiodato sullo scalo, ma solamente per cinque minuti
Pochi anni più tardi, per non correre rischi, il varo del Rex fu organizzato nel mese di luglio. Ma anche questa volta la nave rimase inchiodata sullo scalo per cinque interminabili minuti. Il Roma e l’Augustus erano gemelli nelle fattezze esterne, ma molto diversi fra loro nell’apparato propulsivo. Sovrapponendo le foto delle due navi in navigazione, non si può non notare la grande differenza fra i fumi densi e plumbei della prima e la pratica assenza di gas di scarico della seconda, grazie all’adozione di motori diesel che fecero dell’Augustus la più grande motonave di tutti i tempi. Gli interni furono affidati alla Ducrot di Palermo: più ridondanti per il Roma, dove nella sala delle cerimonie troneggiava la grande statua di marmo della dea omonima e che ora adorna la Stazione marittima di Genova, più sobri per il gemello. Può sembrare paradossale, in un’epoca tutta tesa alla ricerca del lusso e delle raffinatezze di bordo, al servizio di una clientela esigente e benestante, che fra le innovazioni più rivoluzionarie delle due navi rientrasse l’allestimento della terza classe, quella che fino a pochi decenni prima aveva ospitato speranze e angosce in cameroni comuni e in condizioni impossibili, che avevano fatto indignare Charles Dickens e fremere le corde del cuore di Edmondo De Amicis. Quasi per un tributo di riconoscenza verso i milioni di emigranti, che con il loro sofferto esodo avevano alimentato la crescita esponenziale dei traffici attraverso l’Atlantico, la Terza classe del Roma era dotata di cabine a due o a quattro letti, tutte con lavandino privato e acqua corrente. Le antiche garitte da 100 litri di minestra erano sostituite da ristoranti con menu à-la-carte e, dopo pranzo, ci si poteva accomodare nelle sale comuni a fumare un sigaro o, semplicemente, a chiacchierare sdraiati su divani “ricoperti di peluche”.
L’Augustus propose per primo una grande piscina all’aperto con un lido attrezzato con sdraio e ombrelloni
Sull’Augustus, destinato alle rotte calde del Sud America, c’era un’altra novità mondiale presto invidiata e imitata da tutti: una grande piscina all’aperto con un lido attrezzato con sdraio, ombrelloni, aperitivi esotici. I “bagni di sole” dell’Augustus divennero leggendari e tutte le navi successive li vollero adottare: lo stesso modello a cui si ispirano le splendide navi da crociera dei giorni nostri, che hanno individuato in quell’area uno dei motori propulsivi del divertimento a bordo, naturalmente nelle pause concesse dalle slot-machine. La realizzazione del Rex e del Conte di Savoia, i due eredi del Roma e dell’Augustus, coincise con la grande riorganizzazione dell’armamento nazionale del 1932. Tutte le Compagnie italiane, grandi o piccole, vennero fatte confluire in quattro grandi Società, l’Italia, il Lloyd Triestino, l’Adriatica e la Tirrenia, di lì a poco riunite sotto il coordinamento finanziario e gestionale della Finmare. Il Rex e il Conte di Savoia, furono – se ci è consentita l’espressione – due gemelli eterozigoti, essendo stati concepiti e progettati da due società diverse, anzi rivali, la Ngi e il Lloyd Sabaudo, e costruiti in due cantieri anch’essi diversi e rivali, l’Ansaldo di Sestri e il San Marco di Trieste. Ma, come abbiamo appena visto, matrimoni più o meno d’interesse li condussero a vestire la medesima livrea: fin dal loro viaggio inaugurale i fumaioli di entrambe le superbe navi erano dipinti con il tricolore della società Italia.
Cary Grant, James Steward, Douglas Fairbanks, Gloria Swanson, i Duchi di Windsor: tutti affascinati dai liner italiani
Con loro, la marineria italiana si elevò ai più alti livelli mai raggiunti nella sua storia. Il prestigio mondiale, conseguito con la conquista del Nastro Azzurro, l’eleganza degli arredamenti interni, che per il Conte di Savoia recava la firma di Gustavo Pulizer Finali, la memorabile vita di bordo, l’eccezionale livello del servizio che, a sua volta, avrebbe prodotto generazioni di chef e di raffinati barman, contribuirono a creare la leggenda dei transatlantici italiani. Improvvisamente, fu un trionfo mondiale. Tutti i più illustri personaggi del globo, capi di stato, star del cinema, diplomatici, campioni sportivi, volevano farsi fotografare a bordo di un liner italiano, tutti volevano far parte di questa festa tricolore in alto mare. Era diventata una questione di stile, di distinzione, uno status-symbol. Cary Grant, James Steward, Douglas Fairbanks, Jimmy Durante, Primo Carnera, Luigi Pirandello, Enrico Fermi, Gloria Swanson, i Duchi di Windsor, sgomitavano – fra i tanti – per essere ospiti abituali del Conte di Savoia, ma li avremmo ritrovati tutti sul Rex nel viaggio di ritorno. Tuttavia l’immaginazione collettiva aveva forse un po’ esagerato con la proiezione nei propri sogni di questo mondo di fiaba, finendo per distorcerne la percezione reale. Se la vita di bordo sulle navi italiane era considerata eccitante, essa può apparire addirittura austera se letta con gli occhi disincantati di oggi, viziati dalle mille lusinghe delle moderne navi da crociera. Sfogliando il programma della giornata a bordo del Rex del 12 settembre 1939, al mattino siamo attesi al Ponte Sport per “ginnastica in pallestra” (sic!). Alle 14 “concerto musicale”, ripetuto un paio d’ore più tardi. Alle 17, finalmente il cinematografo, preceduto dall’immancabile “Giornale Luce”. Poi aperitivo, corse dei cavalli e, alle 22,30, danze. Sì, le danze che potevano trascinarsi sino alle ore piccole, con tutte le loro intriganti potenziali conseguenze tipiche dell’alto mare. Ma attenzione, alle 7 di tutti i giorni c’è la Messa nella Cappella, sul cui avvenimento non esistono peraltro statistiche relative alla frequentazione da parte dei fedeli. Al di là dei programmi di intrattenimento è la stessa nave che è generosa, è la nave che è prodiga, è la nave che fa sognare e l’atmosfera è sempre di festa.
pubblicato il 4 Ottobre 2020 da admin | in Storie | tag: Conte di Savoia, Great Eastern, Great western railway, Isambard Kingdom Brunel, Kaiser Wilhelm der Grosse, Lloyd Triestino, Mauretania, Raffaele Rubattino, Rex, transatlantici moderni, ville flottante | commenti: 0

 I grandi chef vi "servono" le loro ricette
Ristoranti al mare
I grandi chef vi "servono" le loro ricette
Ristoranti al mare
 Le rotte per i ristoranti d'autore
Voglia di crociera
Le rotte per i ristoranti d'autore
Voglia di crociera
 Splendida la nave, splendide la mete
Navigate con la Fantasia negli Emirati
Con Msc Seaside fino in America
Le migliori vacanze in barca
Splendida la nave, splendide la mete
Navigate con la Fantasia negli Emirati
Con Msc Seaside fino in America
Le migliori vacanze in barca
 Segnalateci la vostra proposta
Case al mare
Segnalateci la vostra proposta
Case al mare
 V'indichiamo la rotta giusta
V'indichiamo la rotta giustain un mare d'investimenti Rotte nell'entroterra
 Segnalateci la vostra proposta
"Navigate" tra le sagre
Segnalateci la vostra proposta
"Navigate" tra le sagre
 Nei borghi i pescatori cucinano per voi
Accessori & partner
Nei borghi i pescatori cucinano per voi
Accessori & partner
 Come e dove rendere la barca unica
Approdi d'autore
Come e dove rendere la barca unica
Approdi d'autore
 Le rotte nei più affascinanti hotel sul mare
Antiquariato & collezionismo
Le rotte nei più affascinanti hotel sul mare
Antiquariato & collezionismo
 Dove navigare fra aste, negozi...
Associazioni di mare
Dove navigare fra aste, negozi...
Associazioni di mare
 Ecco chi tramanda storie e tradizioni
Cantieri e maestri d'ascia
Ecco chi tramanda storie e tradizioni
Cantieri e maestri d'ascia
 Qui gli scafi tornano a splendere
I vostri annunci
Qui gli scafi tornano a splendere
I vostri annunci
 Vendete barche, posti barca, oggetti…
Corsi e patenti nautiche
Vendete barche, posti barca, oggetti…
Corsi e patenti nautiche
 Le migliori scuole per imparare
Le migliori scuole per imparareClick sull'acqua
 Le più belle foto di mare.
Mare by night
Le più belle foto di mare.
Mare by night
 I locali più trend dove approdare
Diving center
I locali più trend dove approdare
Diving center
 Immergersi fra fondali da sogno e relitti
Navighiamo nei musei
Immergersi fra fondali da sogno e relitti
Navighiamo nei musei
 Qui si racconta la storia della navigazione
Presi all'amo
Qui si racconta la storia della navigazione
Presi all'amo
 Bravi pescatori si nasce o si diventa?
Porti turistici
Bravi pescatori si nasce o si diventa?
Porti turistici
 I migliori marina del Belpaese
Lavori in mare
I migliori marina del Belpaese
Lavori in mare
 Come e dove trovare un impiego
Un mare di shopping
Come e dove trovare un impiego
Un mare di shopping
 Abiti, accessori, gioielli e orologi...
Storie e personaggi
Abiti, accessori, gioielli e orologi...
Storie e personaggi
 Per chi naviga con la fantasia
Traghetti ed imbarchi
Per chi naviga con la fantasia
Traghetti ed imbarchi
 Cosa sapere su rotte ed offerte...
Cosa sapere su rotte ed offerte...






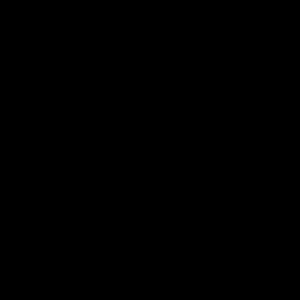











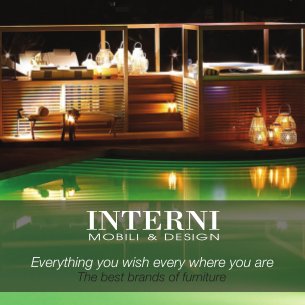




PRONTO SOCCORSO IN MARE
 Sono diversi i possibili problemi di salute che possono subentrare in mare, durante la navigazione,
spesso legati proprio alla vita di mare: da una banale caduta a un tuffo sbagliato, da una puntura di
riccio a una bruciatura di medusa, a un'otite, un'insolazione…
Sono diversi i possibili problemi di salute che possono subentrare in mare, durante la navigazione,
spesso legati proprio alla vita di mare: da una banale caduta a un tuffo sbagliato, da una puntura di
riccio a una bruciatura di medusa, a un'otite, un'insolazione…Cliccate qui per rivolgervi direttamente al medico di mareoline… IL MARE IN TAVOLA
 Mareonline vi invita a scoprire i migliori cibi e vini (ma anche liquori e sigari) da gustare in barca,
indicandovi la rotta per raggiungere i migliori prodotti del mare:
Cibi e Vini
RICETTE DI MARE
Mareonline vi invita a scoprire i migliori cibi e vini (ma anche liquori e sigari) da gustare in barca,
indicandovi la rotta per raggiungere i migliori prodotti del mare:
Cibi e Vini
RICETTE DI MARE
 Mareonline vi propone alcune ricette per cucinare, a casa o in barca, piatti a base di pesce e crostacei.
Mareonline vi propone alcune ricette per cucinare, a casa o in barca, piatti a base di pesce e crostacei.Cliccate qui per scoprire ingredienti e preparazione... SBARCO AL RISTORANTE
 Mareonline vi invita a scoprire i migliori ristoranti lungo le coste del Belpaese, raggiungibili direttamente in barca.
Mareonline vi invita a scoprire i migliori ristoranti lungo le coste del Belpaese, raggiungibili direttamente in barca.Cliccate qui per trovare il vostro ristorante
Cliccate qui per leggere i ristoranti segnalati da voi. MODA E ACCESSORI
 Cliccate qui per scoprire che look deve esibire un vero lupo di mare anche in terraferma...
LE FOTO PIU' CURIOSE
Cliccate qui per scoprire che look deve esibire un vero lupo di mare anche in terraferma...
LE FOTO PIU' CURIOSE"PESCATE" SU FACEBOOK
 Segnalateci le foto più curiose che avete "pescato" su facebook (inviando una e mail a
mareonline@mareonline.it
o lasciando un messaggio sulla sulla pagina facebook di mareonline)
IL ROMANZO
Segnalateci le foto più curiose che avete "pescato" su facebook (inviando una e mail a
mareonline@mareonline.it
o lasciando un messaggio sulla sulla pagina facebook di mareonline)
IL ROMANZO
 cliccate qui per leggere il romanzo il vento e la farfalla di Franco Fabretti
SIAMO TUTTI FOTOGRAFI
cliccate qui per leggere il romanzo il vento e la farfalla di Franco Fabretti
SIAMO TUTTI FOTOGRAFI
 Avete degli "scatti" particolari fatti al mare, in navigazione?
Avete degli "scatti" particolari fatti al mare, in navigazione?Inviateli a mareonline@mareonline.it con vostro nome cognome località fotografata.
Le migliori potrebbero apparire in Home page… Cliccate qui



















