






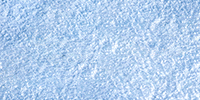











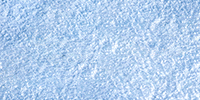





Ma possono emanare anche i suoi profumi

A Livorno, in Accademia, esiste un luogo che evoca i ricordi di molte generazioni di Ufficiali: la Galleria. Si tratta del corridoio che percorre l’edificio principale, a ferro di cavallo, quello storico che abbraccia il piazzale. I pavimenti marmorei di tale Galleria sono stati calcati da migliaia di allievi nei loro spostamenti tra le aule e tutti hanno sempre fatto caso allo zodiaco di costellazioni che passava sotto i loro piedi. Come spesso accade, pochi di quei ragazzi si interrogavano su quelle figure, ma certamente alcuni qualche curiosità sulla genesi delle stesse potrebbero averla avuta. Cerchiamo di soddisfarla insieme a quella di molti visitatori occasionali dell’Istituto. Correva l’anno 1949, l’Accademia era comandata dall’ammiraglio Bigliardi e a San Leopoldo era ospitato il pittore di marina Rudolf Claudus. La Galleria era allora molto più austera e Claudus venne incaricato di realizzare i bozzetti per un progetto volto a migliorare l’aspetto dei pavimenti. L’idea piacque e fu rapidamente eseguita. Il pittore partecipò personalmente, collaborando con i marmisti della ditta Tommaso Lomi alla messa in opera delle tessere dei mosaici. Nel proporre il ricordo di questa attività diversa rispetto al Claudus pittore che conosciamo, riteniamo utile rammentare di lui anche qualche nota biografica e critica. Claudus nasce nel 1893 nei pressi di Vienna da buona famiglia. Entra nella Imperial Regia Marina Austroungarica nel 1908, come allievo macchinista, ma in Marina resterà sino al termine del primo conflitto mondiale, nel 1918, quando l’Austria resterà non solo priva di una Marina ma anche di un accesso al mare. Dopo avere esercitato i più vari mestieri, l’attitudine al disegno unita alla passione per il mare porterà l’ex secondo capo macchinista a specializzarsi nel dipingere il liquido elemento e le navi. A Pola si farà conoscere nell’ambiente della Regia Marina e comincerà una collaborazione destinata, con fasi alterne, a durare circa 46 anni, sino alla morte dell’artista, avvenuta a Roma nel 1964. Dopo essere stato ospite del Conte di Torino, a Brioni, nel 1919, chiamato dall’ammiraglio Acton imbarcherà come pittore del mare sulla corazzata Andrea Doria. Allievo e amico del più noto maestro Ettore Tito, da questi apprenderà la lezione della grande pittura veneziana, la tecnica, i giochi di luce e la vivacità del colore. L’attività di questo periodo della sua vita diviene frenetica e anche se molte delle opere del tempo sono andate perdute per cause belliche, quelle che restano ci danno un’idea sufficiente dell’importanza dei suoi lavori; fra le altre due grandi tele, una conservata al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, a Milano e l’altra, raffigurante una battaglia navale di fantasia, nell’atrio di via Flaminia del Palazzo Marina, a Roma.
Appassionato di automobilismo, partecipò alle gare più importanti d’Italia
Qualche tempo dopo Claudus si trasferisce a Napoli, aprendo studio a Palazzo Donnanna. Nella città partenopea conosce l’opera di un grande pittore di marina, nonché pittore di corte in Inghilterra: Eduardo De Martino. Gli anni fra le due guerre sono di iperattività per Claudus anche dal punto di vista sociale. Ha modo di coltivare amicizie ovunque si sposti; a Milano conoscerà diversi industriali e con loro effettuerà alcune crociere. In particolare potrà coltivare la sua passione per le corse automobilistiche partecipando, da dilettante, alla Targa Florio, alla Mille Miglia, alla Coppa delle Alpi. Fra gli amici dell’epoca conterà Varzi, Gherzi, Taruffi, Nuvolari. Nel suo studio passa tutto il bel mondo del momento: fra i nomi più ricorrenti i Gherzi, i Moizzi, i Lovati, gli Insom, i Calegari, gli Zorzi, e Barzini e poi il Duca di Genova, il Duca d’Aosta, Alsufier, Haide Heffendi, Ventura Messia del Prado. Claudus porta a termine dipinti anche per il Re e per Benito Mussolini, ma stranamente, pur incontrando, soprattutto nel corso del conflitto, numerose personalità del regime e molti ufficiali tedeschi, nessuno di essi pare risulti fra i suoi clienti. Nel ’31 è a Livorno per preparare le sale dell’Accademia Navale alla celebrazione del cinquantenario. Secondo la testimonianza di chi allora gli fu affiancato come aiutante, il Maestro preparava in serie le tele disponendole nello studio. Poi dipingeva con grande velocità prima il colore di fondo del mare, in alto, e poi quello del cielo, in basso. Quindi ribaltava i quadri e li rifiniva inserendovi i vari soggetti navali che gli venivano commissionati. Nel 1935, avendo la sua fama varcato l’oceano, Claudus viene invitato dal presidente Roosevelt negli Stati Uniti. Di questo viaggio restano numerose tracce, fra cui una serie di splendidi acquarelli conservati nel Museo Navale di Annapolis, nel Maryland, su fatti della guerra anglo-americana del 1812. All’inizio della Seconda guerra mondiale Claudus è chiamato a Taranto dove, rifiutando ogni compenso, si adopera per la realizzazione di una documentazione storico-artistica della partecipazione della Regia Marina alla guerra. Nello stesso tempo cura quello che potremmo definire l’interior design di numerose navi da guerra. Il pittore viene anche incaricato di proporre degli schemi di mimetizzazione delle unità che egli realizza con campi geometrici spezzati di vari colori. In quel periodo Claudus realizza anche una serie di dipinti per la Regina Elena, come pure per vari ufficiali che ne fanno richiesta. Nel 1942 nasce il figlio Claudio. Dopo l’armistizio Claudus, che non ha documenti italiani e allo stesso tempo non è riuscito a procurarsene di austriaci, viene arrestato dai tedeschi e detenuto a Genova; poco prima dell’arrivo delle truppe alleate viene liberato, ma solo per essere nuovamente imprigionato con l’accusa di essere tedesco.
I suoi dipinti furono donati allo Scià di Persia, al presidente Kennedy e al Re Faruk
Successivamente liberato, scopre che molte sue cose sono state fatte sparire e gli viene consigliato da alcuni capi partigiani di non indagare troppo sulla fine fatta da circa sessanta quadri. Dal 1947 al 1953 è ospitato dall’Accademia Navale. Un’ospitalità che ricambia con una copiosa produzione di dipinti in gran parte utilizzati per rappresentanza dalle navi scuola in crociera all’estero. Fra i destinatari delle opere anche molte delle personalità del tempo, da Re Faruk al presidente del Venezuela, dallo Scià di Persia al cardinale Spellman, dal presidente Kennedy al Re di Danimarca. Pare che la sua partenza dall’Accademia Navale sia stata in parte dovuta al suo atteggiamento poco rispettoso dell’autorità in quanto tale. Le persone che, pur essendo investite dell’autorità e del decoro di un grado non dimostravano di meritarlo, venivano da lui sbeffeggiate. È così che arriva a Gallese, vicino Viterbo, dove è incaricato di restaurare o fare degli affreschi nel castello locale. I ricordi del tempo sono sfumati; è certo che a Gallese vive e opera per almeno due o tre anni; per un anno alloggia in una casa rurale in località “I colli”, di proprietà di Luigi Maria Hardouin ed è molto amico dei vari componenti della famiglia Severini, residenti nel posto che tuttora posseggono numerose sue opere. Anche loro hanno del pittore un bellissimo ricordo, di persona fuori del comune, spiritosa e socievole; lo descrivono come gran lavoratore, sempre intento a produrre. Nel suo studio mancano le sedie, per evitare che la gente, i numerosi visitatori, si fermino troppo facendogli perdere tempo. Solo un letto è sempre pronto per il suo riposo. Molte delle opere di questo periodo si distaccano dal genere navale o marino precedentemente trattato. Si tratta spesso di animali, campagne, fiori, nature morte, Madonne e persino un fatto storico come la presa di Porta Pia realizzato per gli amici Angelo e Luigi Severini, ex bersaglieri.
Non amava le avanguardie, ma provava simpatia per Impressionisti e Macchiaioli toscani
A questo periodo possono anche essere attribuite diverse vedute romane. Divertente un aneddoto che lo vede regalare agli amici Severini un dipinto quadrato avente uno scopo un po’ particolare: chiudere l’apertura di un camino che quando non utilizzato, convoglia aria fredda nella sala. Pur amando i maestri del passato e frequentando volentieri mostre e musei, Claudus non prova simpatie per le avanguardie che ritiene spesso in malafede. Non frequenta gruppi di pittori, ma nel periodo in cui soggiorna a Forte dei Marmi, ospite del Barone Aloisi, ha modo di conoscere De Chirico, Carrà, Sironi; non condivide, però, il loro modo di esprimersi. La sua stima si orienta invece verso gli Impressionisti, i vecchi Macchiaioli toscani, come Fattori, Lega, Signorini, e poi tutti gli altri, più vicini al suo modo di dipingere. Da Gallese a Roma il passo è breve. Egli si trasferisce in via Angelo Brunetti, centralissima traversa di via di Ripetta, nella casa-studio all’ultimo piano che abita sino alla morte. Non si hanno molte notizie di quell’epoca; qualche frammento lo dobbiamo ai ricordi della compagna Olga e di qualche conoscente. Sappiamo così che non si cura granché della pubblicità; accetta di farsi intervistare e fotografare ma non sollecita questo tipo d’incontri. Rilascia talvolta anche interviste filmate. Vari settimanali italiani, nonché riviste della Marina, pubblicano, col suo consenso, immagini di suoi dipinti. Claudus non vuole avere rapporti con galleristi e mercanti e questo giustifica in parte il relativo oblìo in cui, dopo la morte, la sua opera è caduta. È convinto che pochi prima di lui siano riusciti a dare al mare quel movimento e quei colori che riscuotono tanta ammirazione, ma questa sua convinzione non si trasforma mai in presunzione. È solito lamentarsi di non avere raggiunto risultati soddisfacenti nel ritrarre la figura umana ma la sua modestia si arresta quando si parla del mare; quello si, ammette di saperlo ben interpretare con qualsiasi tecnica pittorica. Dal mare passa con naturalezza alle navi antiche; maggiore fatica e molto tempo gli è costato l’accostarsi alle fredde e lineari navi moderne, ma il risultato è comunque tale che le grigie lamiere che formano precise geometrie, sotto la sua mano riescono ad esprimere, altrettanto bene dei legni che le hanno precedute, l’umanità che trasportano e che le rende quasi creature animate. Molti hanno parlato di una sua eccessiva produzione, cosa vera solo in parte. Va infatti considerato innanzitutto il lungo periodo in cui Claudus si è applicato al cavalletto; inoltre bisogna dire che ha anche lavorato moltissimo, quasi ogni giorno della sua vita. Si capisce che il proprio lavoro piace al pittore, che l’applicarvisi provoca in lui un profondo diletto e che i quadri, quasi per conseguenza, vedono la luce in tempi brevi. La sensazione che ha la sua compagna Olga è che egli stesso risulti meravigliato dal fatto che il disegno sgorghi dalle sue mani con tanta facilità. Ella è per lui che è piuttosto incapace di organizzarsi, un po’ il factotum. È lei che prepara le tele, le tavolozze, tiene puliti i pennelli, fa le ricerche in biblioteca; se necessario, scrive le sue lettere, tiene i contatti, fa anche alcuni viaggi al posto suo in quanto egli accetta solo a malincuore di staccarsi dai pennelli. E, ancora, gli ordina gli appunti, lo aiuta nella preparazione delle mostre e giunge a posare per lui con i costumi, noleggiati per l’occorrenza, necessari per la raffigurazione di personaggi storici che via via compaiono nei suoi dipinti.
Un ammiraglio americano gli scrisse: “Nessuno potrebbe dipingere il mare come Voi…”
Claudus, nel fare arte, spazia fra varie tecniche: dall’olio all’acquarello e alla tempera, sempre con la stessa maestria. Quando è lontano dalle sue tele resta sempre teso allo studio dei soggetti e tutto quello che vede è inteso come tale; di qui le miriadi di disegni che escono di continuo dalle sue infaticabili mani: animali, macchine agricole, persone, tutto è oggetto di studio, ma allo stesso tempo costituisce lo sfogo, il piacere di un attimo, che si esprime in un tratto così sicuro e pulito da lasciare ammirati gli appassionati eventualmente presenti. Questi schizzi che suscitano la delizia degli amici e dei visitatori vengono regolarmente donati. Essi sono l’espressione di una sorta di inquietudine interiore che lo rende continuamente insoddisfatto della propria pittura. Può sembrare che nei quadri di Claudus appaia talvolta qualche eccesso di retorica. Si intuisce l’intento celebrativo. È vero e ciò fa parte del momento storico e della necessità di soddisfare l’esigenza del committente, ma nonostante questo, e potrebbe sembrare un paradosso, Claudus riesce a essere semplicemente verista. Come diceva Giovanni Fattori: “Quando all’arte si leva il verismo, che resta?” Ma quello che soprattutto si percepisce nei dipinti di Claudus è l’aria di mare, l’aria di bordo, la sensazione olfattiva che si prova nelle basi quando le navi possono raccogliere una messe di odori caratteristici e compositi, indescrivibili a chi non abbia vissuto, anche per poco, in quell’ambiente. I soggetti navali e umani dell’artista hanno un’ambientazione naturalistica tutt’altro che secondaria. Le immagini dei mezzi creati e usati dall’uomo si sovrappongono a quelle altrettanto potenti della natura. Claudus compone le sue opere con una successione luminosa di piani. Gli elementi naturali incombono su tutta la composizione; la loro potenza è tale che talvolta è possibile rimuovere ogni altro soggetto dal quadro e lasciarli soli a riempire la tela. L’effetto è notevole e ancora una volta prova la forte sensibilità artistica del pittore, il suo spirito d’osservazione e la capacità coloristica che realizza accostamenti non violenti, ma fusi e smorzati. Claudus affronta qualsiasi tema sul mare; anche il semplice mare senza altre aggiunte e il plauso è pressoché universale: l’ammiraglio americano Robert Carney, dopo avere ricevuto un suo quadro, scrive al pittore: “Nessuno potrebbe dipingere il mare come Voi, senza un’appassionata conoscenza di ciò che esso significa e ciò che rappresenta per gli uomini che vi hanno vissuto…”. Un amico di Claudus, invece, ci riferisce due frasi del pittore emblematiche del suo modo di intendere la pittura: “ Il mare è buono e bello, ma non perdona, neppure sulla tela!” e, ancora, “Vedi, se uno è aviatore devo disegnarlo uccello, se è sommozzatore, pesce, se navigante, lupo, se operaio d’officina, Vulcano… l’importante è che siano belli, belli e nello stesso tempo spaventosi”. E così li ha fatti, sino all’ultimo giorno, quando la morte lo coglie ancora all’opera, con vari dipinti simultaneamente in lavorazione, l’11 aprile del 1964.
Testo di Paolo Bembo, pubblicato sul numero 50 di Arte Navale. Su gentile concessione della rivista Arte Navale. Le immagini sono pubblicate su gentile concessione della rivista Arte Navale. E’ fatto divieto per chiunque di riprodurre da mareonline.it qualsiasi immagine se non previa autorizzazione direttamente espressa dall’autore delle immagini al quale spettano tutte le facoltà accordate dalla legge sul diritto d’autore, quali i diritti di utilizzazione economica e quelli morali.
pubblicato il 28 Giugno 2016 da admin | in Quadri | tag: Claudus, famiglia Severini, Galleria dell'Accademia Navale di Livorno, Gallese, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, pittori di mare | commenti: 1

 I grandi chef vi "servono" le loro ricette
Ristoranti al mare
I grandi chef vi "servono" le loro ricette
Ristoranti al mare
 Le rotte per i ristoranti d'autore
Voglia di crociera
Le rotte per i ristoranti d'autore
Voglia di crociera
 Splendida la nave, splendide la mete
Navigate con la Fantasia negli Emirati
Con Msc Seaside fino in America
Le migliori vacanze in barca
Splendida la nave, splendide la mete
Navigate con la Fantasia negli Emirati
Con Msc Seaside fino in America
Le migliori vacanze in barca
 Segnalateci la vostra proposta
Case al mare
Segnalateci la vostra proposta
Case al mare
 V'indichiamo la rotta giusta
V'indichiamo la rotta giustain un mare d'investimenti Rotte nell'entroterra
 Segnalateci la vostra proposta
"Navigate" tra le sagre
Segnalateci la vostra proposta
"Navigate" tra le sagre
 Nei borghi i pescatori cucinano per voi
Accessori & partner
Nei borghi i pescatori cucinano per voi
Accessori & partner
 Come e dove rendere la barca unica
Approdi d'autore
Come e dove rendere la barca unica
Approdi d'autore
 Le rotte nei più affascinanti hotel sul mare
Antiquariato & collezionismo
Le rotte nei più affascinanti hotel sul mare
Antiquariato & collezionismo
 Dove navigare fra aste, negozi...
Associazioni di mare
Dove navigare fra aste, negozi...
Associazioni di mare
 Ecco chi tramanda storie e tradizioni
Cantieri e maestri d'ascia
Ecco chi tramanda storie e tradizioni
Cantieri e maestri d'ascia
 Qui gli scafi tornano a splendere
I vostri annunci
Qui gli scafi tornano a splendere
I vostri annunci
 Vendete barche, posti barca, oggetti…
Corsi e patenti nautiche
Vendete barche, posti barca, oggetti…
Corsi e patenti nautiche
 Le migliori scuole per imparare
Le migliori scuole per imparareClick sull'acqua
 Le più belle foto di mare.
Mare by night
Le più belle foto di mare.
Mare by night
 I locali più trend dove approdare
Diving center
I locali più trend dove approdare
Diving center
 Immergersi fra fondali da sogno e relitti
Navighiamo nei musei
Immergersi fra fondali da sogno e relitti
Navighiamo nei musei
 Qui si racconta la storia della navigazione
Presi all'amo
Qui si racconta la storia della navigazione
Presi all'amo
 Bravi pescatori si nasce o si diventa?
Porti turistici
Bravi pescatori si nasce o si diventa?
Porti turistici
 I migliori marina del Belpaese
Lavori in mare
I migliori marina del Belpaese
Lavori in mare
 Come e dove trovare un impiego
Un mare di shopping
Come e dove trovare un impiego
Un mare di shopping
 Abiti, accessori, gioielli e orologi...
Storie e personaggi
Abiti, accessori, gioielli e orologi...
Storie e personaggi
 Per chi naviga con la fantasia
Traghetti ed imbarchi
Per chi naviga con la fantasia
Traghetti ed imbarchi
 Cosa sapere su rotte ed offerte...
Cosa sapere su rotte ed offerte...
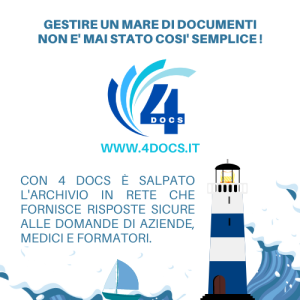





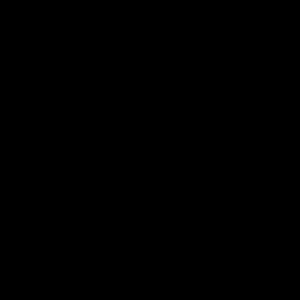



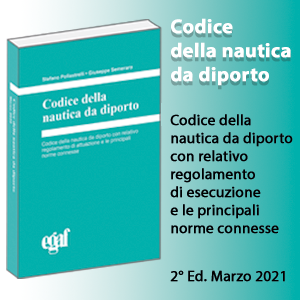




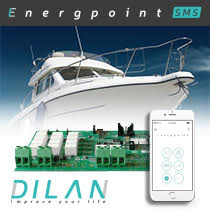
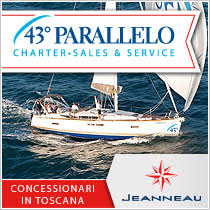

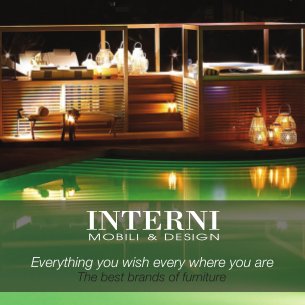


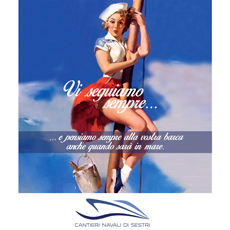

PRONTO SOCCORSO IN MARE
 Sono diversi i possibili problemi di salute che possono subentrare in mare, durante la navigazione,
spesso legati proprio alla vita di mare: da una banale caduta a un tuffo sbagliato, da una puntura di
riccio a una bruciatura di medusa, a un'otite, un'insolazione…
Sono diversi i possibili problemi di salute che possono subentrare in mare, durante la navigazione,
spesso legati proprio alla vita di mare: da una banale caduta a un tuffo sbagliato, da una puntura di
riccio a una bruciatura di medusa, a un'otite, un'insolazione…Cliccate qui per rivolgervi direttamente al medico di mareoline… IL MARE IN TAVOLA
 Mareonline vi invita a scoprire i migliori cibi e vini (ma anche liquori e sigari) da gustare in barca,
indicandovi la rotta per raggiungere i migliori prodotti del mare:
Cibi e Vini
RICETTE DI MARE
Mareonline vi invita a scoprire i migliori cibi e vini (ma anche liquori e sigari) da gustare in barca,
indicandovi la rotta per raggiungere i migliori prodotti del mare:
Cibi e Vini
RICETTE DI MARE
 Mareonline vi propone alcune ricette per cucinare, a casa o in barca, piatti a base di pesce e crostacei.
Mareonline vi propone alcune ricette per cucinare, a casa o in barca, piatti a base di pesce e crostacei.Cliccate qui per scoprire ingredienti e preparazione... SBARCO AL RISTORANTE
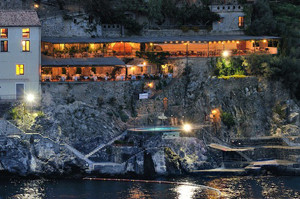 Mareonline vi invita a scoprire i migliori ristoranti lungo le coste del Belpaese, raggiungibili direttamente in barca.
Mareonline vi invita a scoprire i migliori ristoranti lungo le coste del Belpaese, raggiungibili direttamente in barca.Cliccate qui per trovare il vostro ristorante
Cliccate qui per leggere i ristoranti segnalati da voi. MODA E ACCESSORI
 Cliccate qui per scoprire che look deve esibire un vero lupo di mare anche in terraferma...
LE FOTO PIU' CURIOSE
Cliccate qui per scoprire che look deve esibire un vero lupo di mare anche in terraferma...
LE FOTO PIU' CURIOSE"PESCATE" SU FACEBOOK
 Segnalateci le foto più curiose che avete "pescato" su facebook (inviando una e mail a
mareonline@mareonline.it
o lasciando un messaggio sulla sulla pagina facebook di mareonline)
IL ROMANZO
Segnalateci le foto più curiose che avete "pescato" su facebook (inviando una e mail a
mareonline@mareonline.it
o lasciando un messaggio sulla sulla pagina facebook di mareonline)
IL ROMANZO
 cliccate qui per leggere il romanzo il vento e la farfalla di Franco Fabretti
SIAMO TUTTI FOTOGRAFI
cliccate qui per leggere il romanzo il vento e la farfalla di Franco Fabretti
SIAMO TUTTI FOTOGRAFI
 Avete degli "scatti" particolari fatti al mare, in navigazione?
Avete degli "scatti" particolari fatti al mare, in navigazione?Inviateli a mareonline@mareonline.it con vostro nome cognome località fotografata.
Le migliori potrebbero apparire in Home page… Cliccate qui


















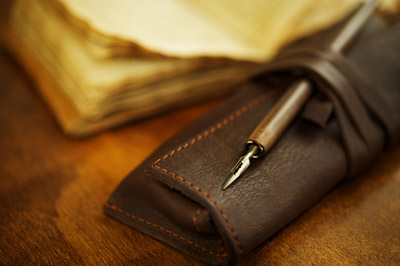

Una ben dettagliata biografia per più importante pittore di Marina italiano. Rod Claudus (alias Rudolph Klaudus). Si consiglia: “Claudus Pittore del Mare” ed. Ufficio Storico della Marina Militare, 1993. Pubblicazione di pregio con testi e illustrazioni originali.