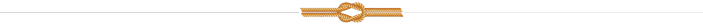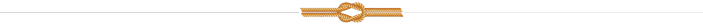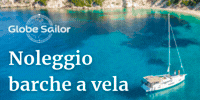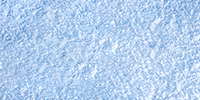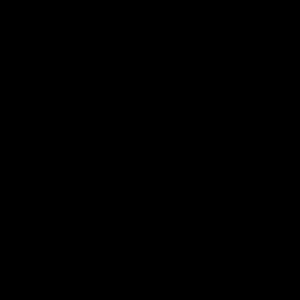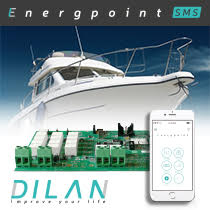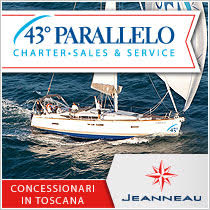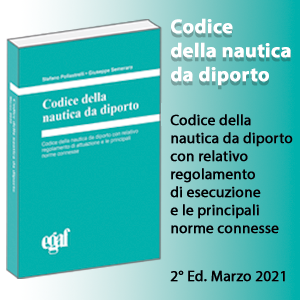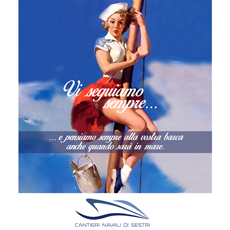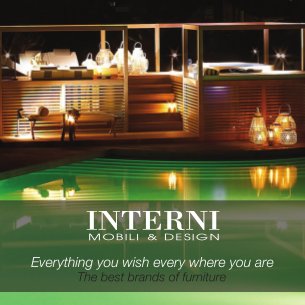Aurora, il simbolo della Rivoluzione
diventato un museo galleggiante

San Pietroburgo, un sabato di fine gennaio. La temperatura si è alzata e il termometro segna, invece dei soliti – 15 gradi, soltanto sette gradi sotto zero. In compenso nevica abbondantemente. Siamo a nord del centro storico, sull’isola Petrograd, circondata per tre lati dalla Neva, mentre a ovest, verso il delta del fiume, c’è un piccolo arcipelago. Non lontano dal vero nucleo più antico della città, che è rappresentato dalla fortezza esagonale dei SS. Pietro e Paolo, voluta da Pietro il Grande a difesa dello sbocco sul Baltico, è ancorato l’Aurora. L’incrociatore Krejser Aurora è il simbolo della Rivoluzione russa del 1917, quando sparò il colpo di cannone che diede inizio all’attacco al Palazzo d’Inverno. Dal 1956 ospita un museo che è parte del Museo centrale della Marina da guerra. La nave ci appare come una silhouette grigia sospesa nel biancore invernale e, allo stesso tempo, stretta nella morsa del ghiaccio. Il vento è pungente; facciamo fatica a salire a bordo, scalando la scivolosissima passerella. Ed eccoci a poppa, sovrastati da alberi, ciminiere, cannoni, scialuppe di salvataggio. Lasciando le impronte nella neve, percorriamo il ponte, che offre la magnifica visione dell’edificio azzurro e bianco dell’Accademia Navale Nahimov. Trovare le scale a prua che portano sottocoperta è un sollievo. Non c’è il comandante ad accompagnarci, perché siamo nel week-end, ma comprendiamo che è difficilissimo orientarci da soli: le scritte di spiegazione e le didascalie sono esclusivamente in caratteri cirillici. Anche per questa ragione il museo non sembrerebbe visitato da stranieri. Quando paghiamo l’ingresso e il permesso per scattare fotografie, ci dicono che è possibile prenotare una visita guidata in inglese. Viktor Stepanov, un anziano e colto signore dalla corporatura robusta, un po’ old style, che parla un inglese decisamente russificato, ci fornisce le chiavi di lettura del percorso espositivo. Si tratta di cinque ambienti, che si attraversano in direzione della poppa. Il primo spazio ospita una piccola esposizione, per fare capire al visitatore come era la vita a bordo, molto dura. Gli uomini dell’equipaggio, composto da 570 persone – di cui 20 ufficiali –, dormivano sospesi su brande agganciate al soffitto; riponevano gli indumenti negli stipetti; seguivano una disciplina ferrea; avevano poco denaro per il tabacco; mangiavano il rancio in piatti metallici, seduti su panche di legno disposte lungo tavolacci anche questi oscillanti.
Nel 1908 i marinai dell'Aurora portarono soccorso ai terremotati di Messina
Nel secondo ambiente è narrata la storia della nave fino agli Anni ’20. La sua costruzione iniziò nel cantiere del Nuovo Ammiragliato di San Pietroburgo nel 1897; fu varata l’11 maggio 1900 e dal 1903 fece parte della Marina russa. Lo zar Nicola II le diede il nome di Aurora, la dea dell’alba. Ebbe il battesimo del fuoco durante la guerra russo-giapponese, quando venne spedita in Estremo oriente, pur essendo inadatta ad attraversare i Tropici. La battaglia di Tsushima del 14-15 maggio 1905 fu un disastro nazionale per la Russia: l’incrociatore perse 99 persone, fra le quali il capitano. Quando fece ritorno sul Baltico venne riparata e usata a lungo come nave scuola per preparare i cadetti dell’Accademia Navale. Nel 1908 i marinai dell’Aurora, “con sì ammirabile esempio di solidarietà e di fratellanza umana, seppero dare soccorso pei primi” durante il “terremoto disastro del 28 dicembre” a Messina. Il Manifesto del Municipio della città siciliana, conservato nel museo, ricorda la medaglia d’oro offerta per gratitudine ai “baldi giovani della Marina Russa” nel marzo 1911. Durante la prima guerra mondiale, l’Aurora prese parte attivamente alle azioni militari sul Mar Baltico e difese Petrograd dai tedeschi. Alla fine del 1916 subì altre riparazioni e modernizzazioni. Nel febbraio 1917 iniziò la rivoluzione democratica: lo zar fu costretto ad abdicare e il nuovo governo venne presieduto da Kerenskij.
Il colpo di cannone che diede il via alla rivoluzione guidata da Lenin fu sparato dall'Aurora
Il Paese aveva sopportato sei milioni di morti durante la guerra. “La gente era stanca e voleva la pace”, spiega la nostra guida, “e questa situazione fu sfruttata per la propaganda socialista”. La nuova rivoluzione si scatenò il 24-25 ottobre (secondo il calendario ortodosso; il 7-8 novembre secondo il nostro, gregoriano) dello stesso anno. Diecimila marinai si riversarono in città; vennero occupate le stazioni, le poste, il telegrafo. La rivolta, con il supporto della popolazione, venne preparata da un Comitato Rivoluzionario insediatosi nel palazzo Smol’nyj, nel settore nord-orientale del centro storico, dove la Neva traccia una grande ansa. Alle 21,40 il primo colpo di cannone dell’Aurora fu il segnale di inizio della Rivoluzione guidata da Lenin. Il terzo ambiente documenta la storia della nave dalla nascita dell’Urss nel 1924, sino alla fine della Seconda Guerra mondiale. L’incrociatore venne ancora una volta modernizzato e adattato a ospitare la Marina e l’Accademia, che avrebbe preparato a diventare ufficiali non più i nobili, ma gente venuta dalle campagne. In questa importante missione il governo sovietico divenne partner della nave, come testimoniato dalla trionfale bandiera del 1924 e dalle fotografie della sua solenne consegna alla presenza di ammiragli celebri dell’epoca. Fino al 1940 l’incrociatore ricoprì questo ruolo di “training ship”. Il 22 giugno 1941 le truppe tedesche invasero la Russia. La gente di Leningrad ascoltò l’annuncio della notizia all’altoparlante. Iniziò la guerra patriottica, ben rappresentata dal realismo socialista di un manifestino con una donna vestita di rosso che, ispirando un senso di protezione, simbolo del Paese, indica la scritta: “La patria ti chiama”.
Duecento marinai dell'Aurora affrontarono i nazisti alle porte di Leningrado con le armi dell'incrociatore
Mentre le truppe naziste raggiungevano Leningrad, l’Aurora era nel piccolo porto di Oranienbaum, ormai così vecchia da non poter andare in mare. Fu deciso di usare l’artiglieria di bordo per difendere la città e i marinai vennero costretti a spostarsi via terra con le armi della nave. Duecento uomini e nove cannoni di 130 mm di calibro spararono per sette giorni contro i carri armati tedeschi. Furono uccisi tutti i membri dell’equipaggio dell’Aurora e le armi completamente distrutte. La loro azione, tuttavia, diede il tempo alla città di fortificarsi e a questi marinai, celebrati come veri eroi, nel 1984 venne dedicato un monumento speciale sul luogo della battaglia, la collina Voronya. Un dipinto del pittore Zaporogec illustra l’evento, mentre in una teca sono conservati parti di armi e un caschetto militare provenienti dal luogo. L’Aurora, allora, non aveva più né difese armate né equipaggio, ma era pur sempre un “oggetto di guerra”, sottolinea la guida, “simbolo del governo sovietico, della Rivoluzione e del Socialismo in Russia”. Per questa sua valenza, la nave venne bombardata dall’aviazione nazista e affondò nel porto di Leningrad, rimanendo con i ponti sotto il pelo dell’acqua per novecento giorni, mentre la città veniva assediata. Nel luglio del 1944, come documenta il dipinto di Pechatin, l’incrociatore fu riportato in superficie con l’idea di ripristinare una nave storica. A bordo vennero posizionate le stesse vecchie armi, simili a quelle originali, perché tornasse a essere simbolicamente come nel 1917. All’interno, la nave divenne la base di una Scuola Navale speciale.
Tra gli ospiti che hanno visitato l'Aurora c'è anche l’astronauta Jurij Gagarin
Il quarto ambiente descrive la storia dell’Aurora dal secondo Dopoguerra agli anni ’90. Nell’ultimo conflitto mondiale la Russia subì 27 milioni di vittime, che causarono molti orfani. Per questi bambini e, in particolare, per i figli dei marinai, che vediamo fotografati in divisa sui ponti della nave, vennero create scuole specifiche. Dal 1948 l’incrociatore Aurora venne posizionato alla fonda dove è adesso e, sino al 1956, fu la base della scuola che ora ha sede nel palazzo dell’Accademia Navale Nahimov. Vivevano a bordo 250 ragazzi e la nave era come una casa per loro. Quando vennero risolti i problemi di riorganizzazione della scuola nel vicino edificio, fu aperto il museo. L’equipaggio che si cura dell’Aurora attualmente è composto da una cinquantina di uomini. I visitatori, dal 1960 a oggi, sono stati più di 30 milioni. Anche numerosi veterani furono ospiti della nave. Tra i personaggi più celebri, l’astronauta Jurij Gagarin fu a bordo dell’incrociatore nel 1965. In questo spazio sono esposti anche pubblicazioni, libri e poesie dedicati nel passato all’Aurora e che ne alimentano il mito. Il quinto e ultimo ambiente è dedicato alle delegazioni ufficiali che hanno visitato la nave, ai doni offerti in occasione della visita. Sono esibiti diversi modellini e alcuni dei disegni migliori, inviati dai bambini, che amano rappresentare questa nave, colpiti nella loro fantasia. In un angolo, presso la biglietteria, sono in vendita brochure, cartoline e qualche gadget. Manca solo una monografia aggiornata e veramente internazionale sull’Aurora. Possibilmente in inglese.
Testo di Linda Kaiser pubblicato sul numero 42 di Arte Navale. Su gentile concessione della rivista Arte Navale.Le immagini sono pubblicate su gentile concessione della rivista Arte Navale. E' fatto divieto per chiunque di riprodurre da mareonline.it qualsiasi immagine se non previa autorizzazione direttamente espressa dall'autore delle immagini al quale spettano tutte le facoltà accordate dalla legge sul diritto d'autore, quali i diritti di utilizzazione economica e quelli morali.