Vasco da Gama, Colombo, Diaz:
un navigatore cinese li anticipò?

Nei primi decenni del XVI secolo l’Europa si sentiva padrona del mondo. La strepitosa stagione delle scoperte geografiche, che nel giro di trent’anni aveva ridisegnato il globo, le aveva dato l’assoluta certezza di essere al centro della Terra. E poiché la Terra era al centro del mondo, l’Europa si poteva ben considerare il cuore dell’Universo. Una forma assoluta di miopia egoistica e presuntuosa le impediva di guardare oltre i propri confini e di immaginare che potessero esistere altre potenze altrettanto, se non più, ricche e progredite. Eppure, agli inizi del ‘500, la Cina aveva già solcato gli oceani da quasi cent’anni e si era spinta fin dove nessuno, fino ad allora, aveva mai osato avventurarsi. L’Età dell’oro delle grandi spedizioni marittime cinesi coincise con l’avvento della dinastia Ming e porta la “firma” di un nome leggendario nell’arte della navigazione cinese, autore di imprese che lo legittimano, senza alcun dubbio, a sedersi accanto ai grandi navigatori nostrani come Colombo, Magellano, Vespucci, Vasco da Gama, Cook. L’ammiraglio per eccellenza, il Grande eunuco, l’Eunuco dei tre gioielli (questo per via di un piccolo scrigno che portava sempre con sé legato alla cintura, contenente le reliquie della sua ormai perduta virilità) era Cheng Ho. Gli eunuchi, pur essendo formalmente utilizzati come domestici di palazzo, costituivano una vera casta privilegiata all’interno della corte imperiale. Se da un lato essi rappresentavano una garanzia nel loro ruolo di guardiani delle migliaia di concubine dell’imperatore, dall’altro disponevano di privilegi eccezionali nell’assistere la sua persona dietro le porte della Città Proibita e, godendo della sua fiducia, costituivano una vera potenza politica. A bilanciare questa particolare nomenclatura, c’era quella dei mandarini, la classe dei burocrati presenti nelle grandi e piccole città cinesi, gli amministratori dell’impero. I mandarini odiavano gli eunuchi di un odio profondo, che affondava le radici nei secoli. “Puzzi come un eunuco” era considerato tra di loro un insulto atroce. La loro religione si basava sul rispetto rigoroso degli insegnamenti di Confucio: mantenere la stabilità e l’ordine, eliminare tutte le cause di disordine che potessero turbare l’armonia naturale delle cose. Le novità non facevano certo per loro.
L'imperatore Yung gli affidò il comando della flotta cinese anche se non aveva mai visto il mare
Cheng Ho, un uomo imponente del peso di più di 100 chili per oltre due metri di altezza e “dall’incedere di una tigre”, fin da ragazzo era stato molto vicino a Zhu Di, il futuro imperatore Yung lo, dimostrandosi con gli anni un eccellente e coraggioso soldato. Quando, nel 1387, Zhu Di sbaragliò le ultime resistenze mongole stabilendosi nella loro antica capitale che chiamò Pechino, lo volle con sé nominandolo comandante in capo della flotta. Cheng Ho, che fino a quel momento non aveva nemmeno mai visto il mare, organizzò e condusse sette straordinarie spedizioni marittime in un arco di tempo compreso fra il 1405 e il 1433. Fin dal 1300 la Cina aveva intessuto solidi rapporti commerciali e strategici con le isole vicine, con la Corea e il Giappone, spingendo poi le proprie giunche fino in Cambogia, a Malacca e a Calicut, in pieno Oceano Indiano. D’altra parte da quasi due secoli i marinai cinesi potevano disporre, unici al mondo, di uno strumento essenziale per affrontare il mare, la bussola, con l’ago perennemente orientato verso il Sud, magico e sacro. Fra il 1405 e il 1417, Cheng Ho condusse le sue prime spedizioni, inoltrandosi nel Sud-est asiatico, la penisola di Malacca, il Siam, l’India, spingendosi poi fino a Malindi e a Mogadiscio, sulle coste africane. L’Africa era piena di sorprese per gli esploratori cinesi, che si imbatterono in un animale con “il corpo di un cervo, la coda di un bue e un corno carnoso senza ossa, con delle chiazze di colore rosso o di un viola brillante. Cammina in modo maestoso e ogni suo movimento è armonioso”. I cinesi non avevano mai visto una giraffa e la sua presenza alla corte imperiale fu chiaramente inteso come un segno della benevolenza degli dei.
Nel 1417 doppiò il Capo di Buona Speranza, scoprendo che l’oceano continuava all’infinito
Fu probabilmente nel 1417 che la flotta di Cheng Ho doppiò il Capo di Buona Speranza e acquisì la consapevolezza che, al di là di esso, l’oceano continuava all’infinito. Una spedizione dopo l’altra, i successi del Grande Eunuco aumentarono il prestigio dell’imperatore, al punto che lo stesso Yung lo pensò che fosse arrivato il momento di consolidare tanta gloria e potenza con qualcosa di strepitoso ed eccezionale, qualcosa che rimanesse per sempre a ricordare lo splendore del suo regno e i fasti della sua dinastia: la costruzione di una intera nuova città, la città più grande del pianeta, la Città Proibita di Pechino. Con l’impiego di tre milioni e mezzo di persone sorvegliate da un milione di soldati, in quattordici anni la Città Proibita, simbolo del fulgore e della potenza imperiale della Cina, fu infine pronta e il 2 febbraio 1421 l’imperatore potè dare inizio ai festeggiamenti per la sua inaugurazione.
Fu lui a guidare re e ambasciatori di tutto il mondo nella Città proibita...
Erano presenti i re e gli ambasciatori di tutti i Paesi più importanti del mondo, giunti a Pechino due anni prima al seguito della quarta spedizione di Cheng Ho. Non era però stato invitato alcun europeo, con i quali non c’erano conoscenze scientifiche da scambiare, né merci da commerciare. Gli europei apparivano un insieme di popoli arretrati e rozzi, con i quali la Cina non poteva né voleva misurarsi. I festeggiamenti durarono due mesi durante i quali l’ospitalità cinese sfoderò tutte le sue meraviglie tra banchetti, libagioni, fuochi d’artificio e raffinate compagnie di concubine messe a disposizione degli ospiti. Infine giunse anche l’ora dei commiati e del ritorno a casa.
...e a ricondurli a casa su giunche di oltre150 metri e 3000 tonnellate di stazza
Cheng Ho venne naturalmente incaricato di guidare una gigantesca spedizione navale per riportare re ed ambasciatori alle proprie terre di origine e, già che c’era, anche per ricercare nuovi Paesi da cui esigere tributi per garantire la pace secondo una filosofia un po’ mafiosa, ma perfettamente funzionante nel sistema introdotto dai cinesi. Ben 107 giunche furono approntate per la bisogna e intere foreste di teak vennero abbattute per la loro costruzione. Le più grandi erano lunghe 155 metri e larghe 61, con nove alberi e un timone centrale nella zona poppiera alto oltre 11 metri. Alcune di esse pesavano oltre 3.000 tonnellate e quando erano in navigazione, scriveva un cronista del tempo, “sono case che assomigliano a grandi nuvole quando dispiegano le loro vele”.
Le bussole gli assicuravano la giusta rotta, i compartimenti stagni lo proteggevano dalle barriere coralline
Oltre che sulla bussola, le giunche imperiali potevano contare su un ingegnoso sistema di compartimenti stagni che consentiva di affrontare con relativa tranquillità le insidie dei mari corallini. Curiosamente pare che i cinesi non conoscessero invece l’uso della clessidra, sostituita per la misurazione del tempo da bastoncini di incenso che ardevano per una durata predeterminata. Non possedevano neppure strumenti per misurare la velocità; tempo e spazio pare che costituissero per i marinai cinesi un concetto unico, inscindibile. La velocità non sembra avere avuto, in quanto tale, alcuna importanza. È interessante notare come Cristoforo Colombo, che pure possedeva diverse clessidre ed era in grado di sapere a quanti nodi stesse veleggiando, si era avventurato attraverso l’Atlantico con caravelle di appena 24 metri di lunghezza e 8 di larghezza, che stazzavano al massimo 100 tonnellate, mentre di compartimenti allagabili in Europa se ne sarebbe parlato solamente alcuni secoli più tardi. Sulle giunche di Cheng Ho il cibo e l’acqua imbarcati erano in abbondanza, sufficienti per una traversata in autonomia di tre mesi o di 4.500 miglia.
A bordo c'erano perfino dei preparati a base di vitamine per combattere lo scorbuto
Ed erano imbarcati anche cani, polli, cavalli: tutto il necessario insomma per sfamare i 30mila uomini della spedizione, compresi preparati vitaminici per prevenire lo scorbuto. Facevano parte dell’equipaggio, oltre ad astronomi e cartografi, anche 180 ufficiali medici per vegliare sulla salute di tutti e un numero imprecisato di concubine per rendere più lieti gli ozi della crociera ai nobili ospiti sulla via del ritorno a casa. Non stupisce che fossero battezzate come “le navi del Tesoro”. Riconsegnati alle loro patrie i re e gli ambasciatori, Cheng Ho riunì i suoi ammiragli e divise la flotta in tre parti, affidandone il comando ad altrettanti eunuchi, con l’ordine di “procedere fino alla fine della terra e raccogliere i tributi dei barbari”. Lui, con le navi più piccole, sarebbe ritornato in patria per assistere l’imperatore, cosa che fece in quello stesso anno 1421. Gli annali delle imprese navali cinesi risultano un po’ confusi e contraddittori sulle date. Alcune fonti collocano la spedizione successiva in epoca antecedente a quella di cui abbiamo parlato. Nel gioco delle date e nei tentativi di ricostruzione storica, sembra che ci siano un paio d’anni mancanti, ossia il periodo fra il 1422 e il 1423. Cosa accadde in quei due anni? Da dove tornavano nel 1423 le malconce navi del Tesoro e quali terre avevano toccato? Gavin Menzes, un ex ufficiale della Marina inglese, ha provato recentemente a dare una risposta a queste domande visitando oltre 120 Paesi, contattando più di 900 biblioteche e musei e ripercorrendo in persona gran parte delle presunte rotte delle navi del Tesoro. Le conclusioni dell’attempato ufficiale britannico sono strabilianti e hanno acceso vivaci discussioni sulla loro attendibilità. Il dibattito non si è ancora concluso, ed è opportuno avvicinarsi con cautela allo straordinario viaggio nel tempo di Gavin Menzes.
La carta di Fra Mauro farebbe credere che la flotta cinese abbia anticipato di decenni grandi scoperte...
La “carta di Fra Mauro” costituisce il primo tentativo di descrivere il mondo intero allora conosciuto. Venne disegnata nel 1459 e sembra delineare abbastanza correttamente la forma e la posizione del Capo di Buona Speranza e delle coste africane occidentali decine di anni prima delle imprese di Bartolomeo Diaz e di Vasco da Gama. Vi è riprodotta anche una giunca cinese e lo stesso Fra Mauro ha aggiunto l’annotazione di aver tracciato la carta sulla base di indicazioni fornite da “persona degna di fede”. Molti studiosi concordano nell’identificare la “persona degna di fede” nel veneziano Nicolò da Conti, un viaggiatore e mercante da anni residente in India, che sicuramente si imbatté nella flotta di Cheng Ho durante il suo soggiorno a Calicut. Per poter fornire rilievi così precisi, Menzes ritiene che Nicolò si sia imbarcato sulle giunche cinesi che, passato il Capo, sarebbero state trascinate dalla forte corrente del Benguela per tremila chilometri lungo le coste dell’Africa atlantica fino al golfo di Guinea, consegnandole quindi alla corrente subequatoriale che descrive un ampio cerchio in senso antiorario, poggiando verso le coste del Sudamerica. La flotta del Tesoro, sospinta anche dagli alisei di Nordest, vi sarebbe stata così “risucchia ta come nello scarico di un lavandino”. Secondo i calcoli di Menzes, verso la fine di settembre 1421 le giunche di Cheng Ho si sarebbero dovute per forza imbattere nelle Isole di Capo Verde, ufficialmente scoperte da Antonio da Noli solo nel 1449. Già, ma come provarlo? Un’antica iscrizione su una stele di pietra di tre metri collocata sulla costa di una di queste isole svelerebbe, sotto le tracce di graffiti più recenti, l’uso di una lingua parlata a Calicut nel XV secolo. Per Menzes non ci sono dubbi: l’autore dell’iscrizione è uno dei tanti interpreti imbarcati sulle giunche imperiali che, da tempo, avevano fissato nella capitale del Malabar la base dei loro traffici e la loro centrale di smistamento. La ricostruzione della rotta delle navi cinesi sembra così essere giunta a un buon punto certo. Le tre flotte, che fin a quel momento avrebbero navigato di conserva, si divisero: una avrebbe fatto vela verso i Caraibi e l’America settentrionale, mentre gli altri due ammiragli avrebbero proseguito verso Sud. Il favorevole gioco delle correnti e l’aliseo che spinge in poppa (l’unica direzione consentita alle navi cinesi) consentirono alle flotte di toccare le coste del Sudamerica? L’affermazione in questo senso di Menzes potrebbe apparire un po’ troppo ottimistica e sbrigativa. Ma un’antica carta geografica turca sembra rendere meno temerarie le conclusioni del ricercatore inglese. Alla corte portoghese di Enrico il Navigatore, si faceva un gran parlare di un documento veneziano del 1428 che riproduceva il mondo con dettagli sul Capo di Buona Speranza e sullo Stretto di Magellano. Pare che un marinaio di Colombo - che, come sappiamo, non navigò mai al di sotto dell’equatore - avesse con sé un pezzo di quella carta, la parte relativa all’America meridionale, e che l’avesse ancora con sé quando fu catturato dai turchi. Purtroppo oggi quella carta non esiste più ma Piri Reis, un cartografo ottomano, l’aveva inserita nel 1513 nel suo grande planisfero formato dai tasselli di carte di più diversa provenienza.
.... arrivando a Capo Horn addirittura otto anni prima di Magellano
Ed ecco la sorpresa. Confrontando il documento di Piri Reis con una carta geografica contemporanea, i contorni della Terra del Fuoco, delle isole che circondano Capo Horn, dei picchi andini sembrano terribilmente coincidenti. Magellano avrebbe scoperto lo stretto che porta il suo nome solo otto anni più tardi. D’altra parte Pigafetta, il cronista del grande portoghese, scrive che lo stesso Magellano, dopo aver attraversato il Pacifico, incontrò il re di Limasava e “fece portare la sua carta da navigatore e gli disse come trovò lo stretto per venire a lui”.
Per quali misteriose ragioni nessuno può consultare la carta di Piri Reis nascosta nel museo Topkapi?
Per ragioni mai chiarite, la carta Piri Reis è conservata gelosamente, anzi blindata, nel museo Topkapi di Istanbul dove nessuno può consultarla, quasi fosse un segreto di Stato. Il mistero si infittisce e l’eccitazione sale quando Menzes scopre nel Minnesota un’altra carta disegnata nel 1424 dal veneziano Zuane Pizzigano, che descrive con chiarezza quattro isole al largo dell’Atlantico, il cui profilo è sorprendentemente coincidente con quello dell’arcipelago delle Antille.
Cristoforo Colombo possedeva due mappe che gli indicavano la via per scoprire i Caraibi e l'America?
Ne deriverebbe che Cristoforo Colombo poteva contare non su una, ma addirittura su due mappe pronte a indicargli la via sicura per “scoprire” i Caraibi e l’America. Quando il suo equipaggio, scoraggiato dalla inconcludente ricerca delle Indie, minacciò la ribellione, il grande genovese fu pronto a giocarsi la testa se entro tre giorni non fossero riusciti a toccare terra, cosa che avvenne regolarmente dopo 72 ore esatte: fortuna, abilità marinaresca o semplice sbirciatina alle carte già tracciate che Colombo teneva sottochiave nella sua cabina? D’altronde, cosa voleva dire il cartografo Paolo Toscanelli in una sua lettera indirizzata a Colombo nella quale affermava che “il navigar da Levante a Ponente non sol sia possibile ma vero, come per la carta ch’io ti mandai si dimostra”? Lasciamo i misteri di Colombo e torniamo a quelli dei nostri amici cinesi. Osservando la celebre carta di Waldseemuller, famosa per aver consacrato l’impresa e il nome stesso di Amerigo Vespucci, non si può negare che il tracciato del versante Pacifico riservi inaspettate sorprese per la chiarezza e i dettagli con cui il documento sviluppa le coste dell’intero continente, dall’Ecuador all’isola di Vancouver in Canada, collocandole alla latitudine e alla longitudine corretta. Anche qui Menzes non ha alcun dubbio: l’autore di quella celebre carta, come di quella precedente detta “del Cantino”, aveva gli occhi a mandorla, ed era l’unico che quelle coste e quei lidi poteva dire di conoscerli bene essendoci stato e avendoli disegnati. Ma anche ammesso che queste carte riproducano terre e rotte scoperte e tracciate da navigatori che avevano preceduto di parecchi decenni Diaz, Colombo, Vasco da Gama, Magellano, come si può affermare con sicurezza che questi antichi navigatori fossero davvero cinesi?
La prova della presenza della flotta cinese a Rio de Janeiro? Le uova azzurre della galline date a Magellano...
In proposito lo studioso britannico ha in serbo molti indizi, a suo giudizio “quasi prove”. Le galline che Magellano scambiò nei pressi di Rio de Janeiro con ami da pesca o coltelli non avevano nulla a che fare con i polli europei vuoi per la loro stazza, vuoi per il loro piumaggio, vuoi, soprattutto, per il colore delle uova, di un bell’azzurrino intenso: tutte caratteristiche tipiche del pollame asiatico. E poiché i polli non volano... Ma non è tutto. Nel letto del fiume Sacramento, in California, si troverebbe il relitto di una nave che, per dimensioni e per il materiale usato, sarebbe appartenuto alla flotta cinese del Tesoro, mentre nei pressi di San Francisco molti indizi confermerebbero addirittura l’insediamento di una colonia cinese che vi avrebbe esportato la coltivazione del riso, sconosciuto da quelle parti del mondo. Nei musei della California sono conservate numerose porcellane dell’epoca Ming che recano una tonalità di azzurro più chiaro a causa del particolare tipo di cobalto usato, utilizzato esclusivamente durante il ristretto periodo dell’imperatore Zhu Di e del suo eunuco Cheng Ho. Menzes non ha dubbi. Nel periodo compreso fra il 1421 e il 1423, i famosi “anni mancanti”, la grande flotta cinese del Tesoro avrebbe attraversato l’Atlantico e qui si sarebbe divisa in almeno tre gruppi compiendo una doppia circumnavigazione del Globo, da Nord e da Sud, prima di gettare nuovamente le ancore nei porti del Celeste Impero. Secondo Menzes l’eredità della flotta del Tesoro è ancora lì, in almeno 24 relitti di giunche già individuati, sepolti sotto cumuli di sabbia e fango su tutte le coste del mondo, dalla California, all’America meridionale, all’Africa, all’Australia. Tutte le principali carte geografiche dell’epoca, da quella di Fra Mauro a quella del Cantino, dalla Carta del Mondo del 1428 (ora scomparsa) a quella di Waldseemuller, sarebbero state tracciate sulla base di precedenti mappe cinesi e tutti i grandi navigatori della nostra storia ne possedevano un esemplare, che ha consentito loro di orientare sicuri le loro esplorazioni e di mettere a tacere con cognizione di causa i dubbi e i fermenti di equipaggi ignari e spaventati. Ma, siamo ritornati alla storia ufficiale, quando le flotte degli ammiragli di Cheng Ho rientrarono in patria, scoprirono che tutto, davvero tutto, era cambiato. Il loro principale paladino, il tenace sostenitore delle grandi spedizioni navali, l’imperatore Zhu Di, era ormai morente e, con il suo successore, i mandarini avevano preso il sopravvento imponendo tutto il loro rifiuto per le novità e per i contatti con l’esterno. La Cina stava chiudendosi in sé stessa, i cantieri restavano senza lavoro e, per editto imperiale, “tutti i viaggi delle navi del tesoro devono cessare”. Le giunche furono fatte a pezzi o lasciate marcire all’ormeggio. A suggellare il rifiuto completo con il passato, venne ordinata la distruzione sistematica di tutti i documenti e i rapporti di viaggio, delle carte geografiche, delle mappe e di qualsiasi traccia che potesse in qualche modo riallacciarsi a quelle esperienze che ora venivano ripudiate. La Cina entrò nella notte del suo volontario isolamento e le imprese di Cheng Ho, quelle riconosciute e quelle solo ipotizzate, caddero per secoli nell’oblio. Alla furia autodistruttrice sono miracolosamente sfuggite due stele in pietra erette a Liu Shia Chang dallo stesso Grande Eunuco che, dopo 600 anni, continua a inviarci la sintesi della sua leggenda racchiusa nell’incisione del suo enigmatico messaggio: “più di tremila paesi” visitati e “immensi spazi d’acqua nell’oceano, per posare gli occhi su regioni barbare lontanissime”.
Testo di Giorgio Grosso pubblicato sul numero 54 di Arte Navale. Su gentile concessione della rivista Arte Navale.Le immagini sono pubblicate su gentile concessione della rivista Arte Navale. E' fatto divieto per chiunque di riprodurre da mareonline.it qualsiasi immagine se non previa autorizzazione direttamente espressa dall'autore delle immagini al quale spettano tutte le facoltà accordate dalla legge sul diritto d'autore, quali i diritti di utilizzazione economica e quelli morali.
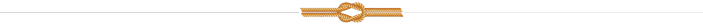
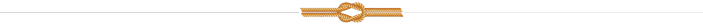
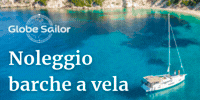







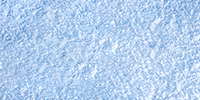

























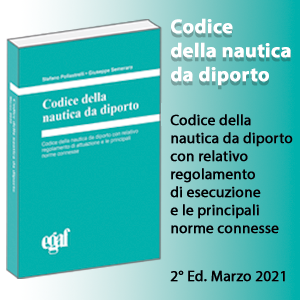
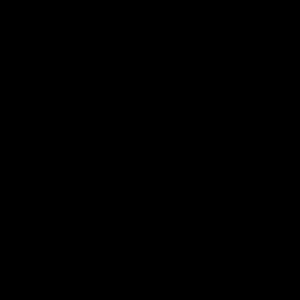


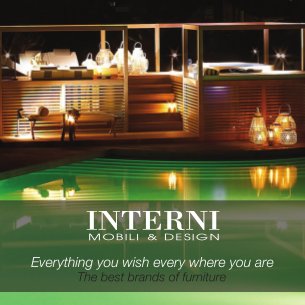




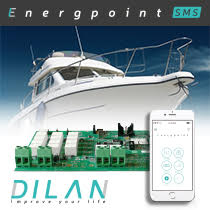

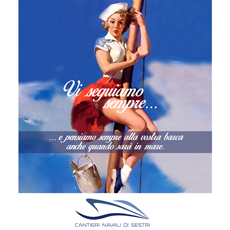

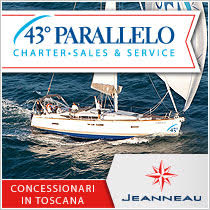



... questa e' una splendida "chicca"... !!! Bellissimo articolo, oltre che interessantissimo... complimenti all'autore, o agli autori...