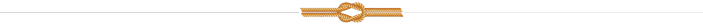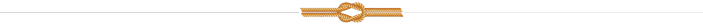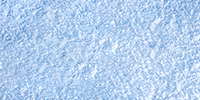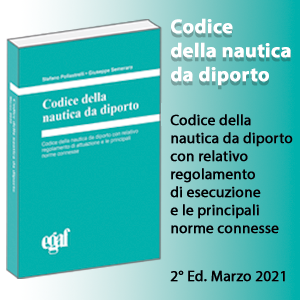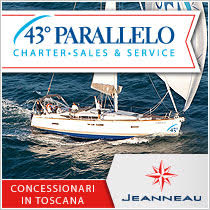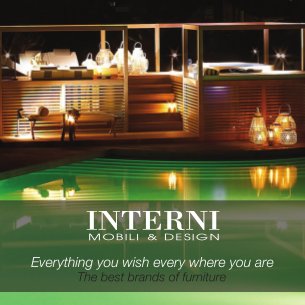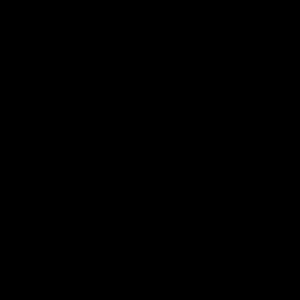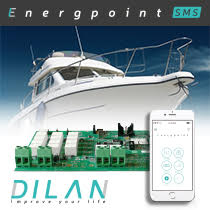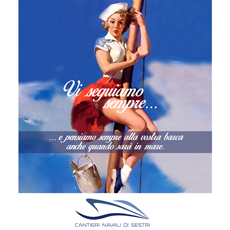Viaggi in nave da incubo. Quello vissuto
da Charles Dickens è tutto da leggere

Fra i numerosissimi racconti di Charles Dickens ce n'è uno, meno noto di molti altri, in cui l'autore di David Copperfield e de Le avventure di Oliver Twist (ma anche de Il naufragio della Golden Mary) ci racconta la sua traversata da Liverpool ad Halifax e Boston e ritorno, inserita nel suo libro Note Americane. La nave è il Britannia, un vapore in legno di 1200 tonnellate mosso da pale laterali e dotato anche di ampia velatura, come era in uso all’epoca. Il proprietario della nave poteva ben essere orgoglioso del Britannia, concepita con criteri di lusso e di robustezza, dotata di cabine a due/tre posti con divano, stipetto e lavabo personale. L’affidabilità della nave, soprannominata Ognitempo, divenne celebre quando nel gennaio 1844 riuscì a superare la barriera del mare improvvisamente ghiacciatosi nella baia di Boston. Ma per Charles, alla sua prima esperienza marinara, tutto ciò non è sufficiente e descrive le peripezie per adattarsi alla vita di bordo con caustica ironia.
Sul Britannia non voleva avere nulla da spartire con l’equipaggio e con i problemi della navigazione
L’intellettuale Dickens non ha (né vuole avere) nulla da spartire con l’equipaggio e con i problemi della navigazione: lui e sua moglie sono rispettabili passeggeri di prima classe che hanno pagato ben 195 dollari per la traversata: i venti, le burrasche, gli scricchiolii sinistri della nave sono solo fastidiosi inconvenienti lasciati alle cure di altri. E neppure suscitano troppo entusiasmo la tecnologia e il comfort che hanno fatto passi da gigante, la vela che ha lasciato il posto al vapore, la capacità di trasporto aumentata (Dickens parla di 86 passeggeri), le cabine dotate di oblò, la cucina ricca e il bar è ben fornito. Durante l'emozionante fase di imbarco e di accoglimento a bordo, tutti i passeggeri seguono con indulgente distacco il carico delle provviste, “tocchi di carne e verdure, dozzine di rosei porcellini da latte, quantità smisurate di manzo, vitello, maiale, pollame”, e l’imbarco del latte fresco rappresentato da due mucche, alloggiate nella cow- room, un’innovazione tanto geniale quanto pratica per migliorare il livello di comfort della nave e dei passeggeri.
La cabina di lusso per lui era una ridicolissima scatola impraticabile soffocante e puzzolente...
La “cabina di lusso” prenotata alcuni mesi prima, viene definita una “ridicolissima scatola, decisamente impraticabile” soffocante e pregna di strani odori, da dove gli ospiti sognano di uscire tentando “ogni sorta di contorcimenti nella speranza di varcare l’angusta porticina”. La trapunta di cui è dotata la cabina è “simile a una ingessatura chirurgica ed è collocata sul più inaccessibile degli scaffali”. Gli enormi attaccapanni (che verranno subito sistemati altrove) trovano un alloggiamento tanto comodo “quanto quello di una giraffa persuasa o forzata a entrare dentro un vaso da fiori”.
... e più stretta della cuccetta poteva esserci solo una bara
Quanto alla cuccetta “di più stretto, per dormire, c’è solo la bara”. Il salone delle feste, uno dei punti di orgoglio della nave, è “un locale lungo e stretto, non molto diverso da un grande carro funebre con le finestre sui fianchi, con una malinconica stufa su un lato dove 3 o 4 infreddoliti camerieri si scaldano le mani, e sull’altro lato un lunghissimo tavolo che si estende per tutta la sua cupa dimensione”. La cameriera mente, per misericordia, sulla affidabilità e sicurezza dei viaggi in gennaio, assicurando che basteranno 12 giorni per completare la traversata, che invece ne richiederà 18. Ma naturalmente, la parte più emozionante della traversata deve ancora venire.
Come non bastasse la tempesta fa volare gli specchi in cabina e rovesciare ogni cosa...
La mattina del terzo giorno di navigazione, il risveglio per la famiglia Dickens è un po’ brusco: tutti gli oggetti della cabina prendono a danzare “come delfini”, lo specchio si è staccato dalla sua posizione e si è spostato sul soffitto, la porta è scomparsa “e se ne è aperta un’altra sul pavimento”. La conclusione per Dickens è semplice: la nave si è capovolta! Ma non fa a tempo a compiacersi per la rapidità e la sagacia della sua deduzione, che tutto riprende la posizione originale per riassestarsi dalla parte opposta. La nave procede a balzi, con tuffi a capofitto e piroette verso il cielo, sbandando paurosamente senza sosta. “Vento di prua” spiega il cameriere incaricato del rito dello svuotamento dei pitali e del rifornimento dell’acqua dei lavabi, e nella immaginazione del grande scrittore la prua della nave assume le fattezze di un volto umano contro il quale si scatenano “mille Sansoni intenti a ricacciarlo indietro e a dargli un colpo fra gli occhi ogni volta che avanza di un pollice. E immaginate che la nave, con tutte le vene del suo immenso corpo gonfie di rabbia per quel maltrattamento, giuri di avanzare anche a costo di morire”. Mobili, casse, camerieri, bottiglie schizzano e rimbalzano da tutte le parti con rumori sinistri.
Ma il peggio è il mal di mare che lo riduce alla semiincoscienza
Allora sopraggiunge il mal di mare. Non quello tradizionale, ben conosciuto da tutti, bensì uno stato di semiincoscienza e di apatia, privo di desideri, rimpianti, curiosità che Dickens consuma, immobile e sopraffatto, nel letto della sua cabina. La tempesta ha lasciato il segno: le protezioni delle pale laterali sono state strappate via e le ruote inondano il ponte di spruzzi di mare, le vele sono a brandelli, il sartiame è aggrovigliato e grondante d’acqua, il fumaiolo è ricoperto da uno strato di sale, la scialuppa di salvataggio è sfasciata e penzola in aria “come un fastello di assi senza senso”. Burrasche a parte, le giornate a bordo si susseguono tutte uguali, ritmate dal suono della campana. Qualche chiacchiera dopo il breakfast, il pranzo dell’una, il the al pomeriggio davanti al camino acceso, la cena ricca di carne di vari tipi “fra cui non manca mai il maiale arrosto da prendere come medicina”, il gioco delle carte e un buon bicchiere di brandy allungato con acqua tiepida, la buonanotte del capitano con le sue false assicurazioni sul deciso miglioramento del tempo per l’indomani.
E, come non bastasse, nei pressi di Halifax, la nave s'incaglia su un banco di sabbia
Per fortuna, ormai nei pressi di Halifax, la nave offre l’emozionante diversivo di incagliarsi su un banco di sabbia e i passeggeri vengono arruolati nel fondamentale compito di spostarsi tutti a poppa per sbilanciare la nave e consentirle di liberarsi. Ma il tentativo non ha successo e il capitano decide di inviare una scialuppa a terra per chiedere soccorso. Con generosa prontezza, annota Dickens, molti passeggeri si offrono di imbarcarsi sulla scialuppa per assistere l’equipaggio ovviamente “nell’interesse generale, e non perché pensassero che la nave fosse in una posizione rischiosa o che potesse rovesciarsi”. Il capitano, che è un vecchio lupo di mare, farà tesoro di questa esperienza e riuscirà a disincagliarsi da solo quando, 5 anni dopo, si imbatterà nella stessa avventura nel medesimo tratto di mare. Sei mesi più tardi Charles Dickens è sulla rotta di ritorno, questa volta a bordo di un veliero. L’esperienza della sua prima traversata ha lasciato il segno: ora è un uomo diverso, è scomparsa la sdegnosa e distaccata ironia con cui affrontava i disagi della vita di mare ed ha capito che la furia delle tempeste o le bizzarrie del vento sono fatti che riguardano anche lui.
Ma nel viaggio di ritorno tutto appare più bello, perfino due giorni di tempesta...
Il suo racconto ora è ricco di annotazioni sulle condizioni meteorologiche, sul rilevamento del punto nave, sull’emozione di incrociare altre vele, sulle danze dei delfini in prua, sul timore degli iceberg. Anche con l’equipaggio il rapporto è cambiato e gli elogi si sprecano: due giorni di tempesta passano in fretta “sotto la guida del nostro bravo e cordiale comandante”. La nave trasporta anche un centinaio di passeggeri di terza classe; sono emigranti che, delusi e sfortunati, tornano a casa dopo che il sogno americano è svanito. Le condizioni dei loro alloggiamenti sono spaventose: promiscuità, nessuna assistenza medica, cibo praticamente inesistente, assenza di bagni. Dickens ne rimane colpito e scandalizzato: “Se c’è una classe che merita la protezione e l’assistenza del governo, questa è la classe di coloro che sono costretti ad abbandonare la patria per andare alla ricerca dei mezzi per sopravvivere”. Questa volta il vento soffia costante nella giusta direzione e la “splendida nave” fende maestosamente l’acqua. Ora il tuffarsi dello scafo nella gola delle onde e il riemergere nel bianco accecante della spuma è “qualcosa di nobile che ci riempiva di una gioia e di un orgoglio inesprimibili”. Sono passati i tempi in cui Dickens faceva lo spiritoso sugli specchi e sulle porte che cambiavano posizione! L’avvistamento di Cape Clear (“che Dio lo benedica”) allarga il cuore di Charles alla gioia trepidante per il ritorno a casa. Dickens, dopo tanto mare, resta affascinato dal verde delle colline e dei prati: “Nessuna lingua, né la mia penna, basterebbero a descrivere la bellezza dei campi (sembravano così piccoli!), delle siepi, degli alberi; le graziose villette, le aiuole, i vecchi cimiteri; dolci piaceri di quel viaggio che, nel breve volgere di un solo giorno d’estate, addensava le gioie di molti anni che si concludono a casa, con tutto ciò che ce la rende cara”.
Adattamento per mareonline del testo di Giorgio Grosso pubblicato sul numero 39 di Arte Navale. Su gentile concessione della rivista Arte Navale. Le immagini d’archivio sono pubblicate su gentile concessione della rivista Arte Navale. E’ fatto divieto per chiunque di riprodurre da mareonline.it qualsiasi immagine se non previa autorizzazione direttamente espressa dall’autore delle immagini al quale spettano tutte le facoltà accordate dalla legge sul diritto d’autore, quali i diritti di utilizzazione economica e quelli morali.