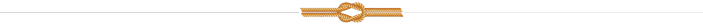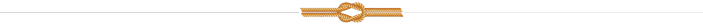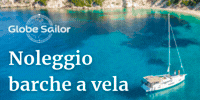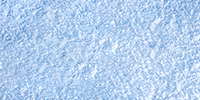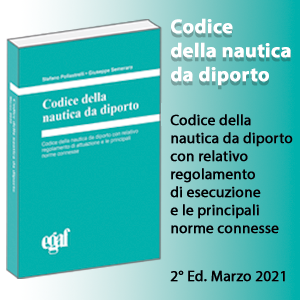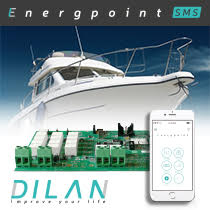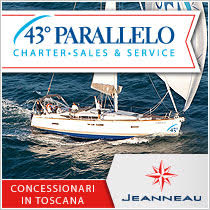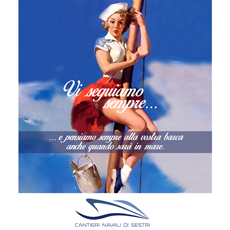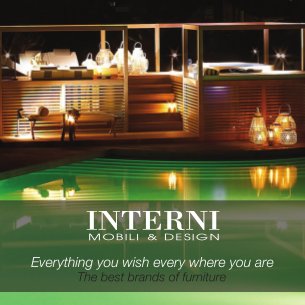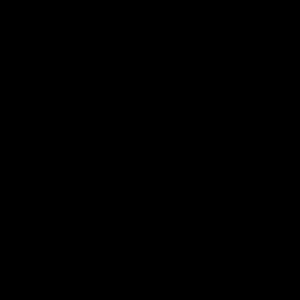Il mito dei Lloyd's? Fu promosso
da una serie di note sul registro

Verso la fine del '600 incominciò a diminuire la consistenza dei nuovi colonizzatori in viaggio verso l’America, mentre si stava ridimensionando l’illusione di poter contare su un flusso inesauribile di carichi di metalli preziosi: le navi spagnole trasportarono meno di 443 tonnellate d’argento e appena 469 chili d’oro, ben poca cosa rispetto a 50 anni prima, quando le rimesse erano state superiori di 7 e di ben 100 volte, rispettivamente. Lo scenario era così cambiato da costringere pirati e bucanieri, che avevano fatto dell’Atlantico e dei Caraibi il loro teatro d’azione preferito, a indirizzare altrove le proprie attenzioni: il mar della Cina e l’Oceano Indiano per esempio, o il Pacifico solcato annualmente dal favoloso galeone di Manila.
La pace di Utrecht segnò inesorabilmente la fine della corsareria
Con il crescere delle esigenze della “nuova” popolazione americana si era andato così consolidando, parallelamente, il fenomeno dei traffici più propriamente commerciali, costituiti da beni di consumo come legnami o prodotti delle ricche piantagioni di canna da zucchero, insidiato solo dalle scorribande dei pirati e dei corsari ancora nostalgicamente legati ai mari dei Caraibi, fino a quando i principali Paesi coinvolti decisero, con la pace di Utrecht, che era meglio tutelare l’interesse comune, piuttosto che continuare a recarsi reciproco danno con l’aiuto, legale ma suicida, dei rispettivi corsari. E per quest’ultimi fu il colpo di grazia. È ormai alle porte l’Era dei Lumi, capace di rischiarare le tenebre dell’ignoranza, della superstizione, dell’intolleranza e del privilegio. La ragione spinge all’innovazione scientifica, al progresso alle nuove idee e con esse l’apertura di nuovi orizzonti, di nuovi contatti, di nuove informazioni e l’occasione per nuove ricchezze. Lo scenario dei traffici marittimi attraverso l’Atlantico è causa ed effetto di questa ventata innovatrice: non c’è più spazio per l’avventura in una realtà che vuole cavalcare in fretta le crescenti necessità di scambio fra l’Europa e il Nuovo Mondo che si sta organizzando e, soprattutto, fra l’Inghilterra e le sue colonie della costa orientale americana.
Nel giro di pochi anni i brigantini presero il posto degli obsoleti galeoni
Nel 1770 l’Inghilterra, con oltre 7mila navi per una stazza complessiva di 880mila tonnellate, possiede la più potente marina del mondo e i suoi traffici esigono ormai regolarità nelle partenze, strumenti di bordo adeguati e capacità di prevedere con sufficiente precisione il proprio arrivo. In breve, sicurezza, affidabilità e puntualità. Le navi non erano più i galeoni, pericolosamente alti di poppa, con prue arrotondate a forma di mela, appesantiti da fregi e ornamenti; ma non erano ancora i velieri slanciati e veloci che nel secolo successivo avrebbero spinto i progettisti americani e inglesi a superarsi in sempre più ardite soluzioni tecniche. Sta nascendo l’epoca dei brigantini, eleganti legni a due o tre alberi che facevano della capacità di carico più che della velocità il loro punto qualificante. Ma con il tumultuoso sviluppo dei traffici marittimi e le prospettive di facili guadagni per armatori anche improvvisati, che non esitavano a lanciare nella sfida attraverso gli oceani legni affidati più alla benevolenza divina che alla sicurezza delle proprie strutture, si incominciava a imporre l’esigenza di fare un po’ d’ordine e di razionalizzare questo mondo marinaresco, destinato ormai ad assumere dimensioni e caratteristiche industriali.
L'intuizione di Edwuard Lloyd fu quella di stampare le informazioni che passavano nella sua coffee house
La storia è curiosa e inizia a Londra in una sera di nebbia dei primi del ‘700. Il signor Edward Lloyd aveva aperto fin dal 1689 in Tower Street un bar, o meglio uno di quei locali vicino al porto dove è confortevole sedersi al caldo su ampie poltrone di pelle per bere un punch o una birra e fare quattro chiacchiere sui velieri appena approdati, su quelli in partenza, sulle avventure raccontate da qualche marinaio in cerca di conforto o di imbarco, sull’andamento del mercato delle spezie: insomma, quello che gli inglesi chiamano coffee house. La più antica notizia ufficiale relativa al bar del signor Lloyd è riportata sul “London Gazette” del 18 febbraio 1689: il signor Edward Brandbury promette una ghinea in premio a chi fornirà informazioni su “un uomo di media statura, dal cattivo odore, dai capelli neri e ricci, butterato in viso, con una vecchia giubba marrone da cavallerizzo e un cappello nero” che gli aveva derubato 5 orologi, appunto nei locali del “Lloyd’s coffee house”. Non sappiamo se il ladro fu mai scoperto, ma dobbiamo essergli grati per questo involontario graffito della nostra storia. Il locale prosperava, gli avventori apprezzavano le bevande servite da Edward e la piacevolezza dell’ambiente, dove era possibile scambiarsi preziose informazioni di prima mano sui propri affari. Lloyd pensò che era arrivato il momento di ingrandirsi. Così, seguendo l’esempio di altri titolari di locali simili, trasferì la sua coffee house al numero 16 di Lombard Street, nel pieno centro commerciale e finanziario di Londra, accanto al Royal Exchange, dove i mercanti avevano i loro uffici e dove concludevano le transazioni più importanti. Ma era nell’atmosfera rilassata e socializzante delle coffee houses che le novità, le informazioni, le previsioni e persino i pettegolezzi trovavano il loro ambiente naturale per il loro combinarsi e per la loro diffusione, al punto che questi locali – veri punti di riferimento per gli uomini d’affari – finirono per specializzarsi a seconda degli interessi specifici dei loro frequentatori. L’idea geniale di Edward Lloyd fu quella di raccogliere le informazioni che transitavano nel suo locale e di stamparle su un bollettino trisettimanale che lui chiamò “Lloyd’s News”. Inizialmente il foglio, che costava 1 penny, riportava notizie di carattere generale su avvenimenti accaduti all’estero, sulla guerra, sulle esecuzioni, sugli affari del Parlamento e solo più tardi, nel 1760 ad opera di un discendente di Edward, il bollettino si specializzò nel campo navale e marittimo, prendendo il nome di “Lloyd’s List”. È curioso ricordare che le notizie, prima di essere stampate sul bollettino, venivano annunciate a voce stentorea da un cameriere dall’alto di un pulpito.
Grazie a Thomas Jemson il foglio di news e pettegolezzi si trasformò nel Lloyd's Register of Shipping
Thomas Jemson, il discendente e continuatore dell’idea del signor Lloyd, si era accorto che l’enorme sviluppo dello shipping in Inghilterra e altrove non era stato accompagnato da alcuna rilevazione sulle caratteristiche delle navi, sulla loro capacità, sul loro grado di sicurezza, sulla loro stessa esistenza. Egli prese così ad annotare diligentemente in un quadernetto, o registro che dir si voglia, tutte quelle informazioni che non gli era difficile raccogliere nell’ambiente fumoso ma denso di notizie della sua coffee house. A poco a poco il quadernetto di Jemson andò sempre più ingrossandosi, sino a diventare un vero e proprio registro, anzi Il Registro, il famoso Lloyd’s Register of Shipping. Il Registro ebbe un successo clamoroso: tutti lo volevano consultare, dagli armatori ai commercianti, dai cantieri agli assicuratori. Le ragioni che fecero del Lloyd Register un best seller erano semplici: esso costituiva l’unica fonte d’informazioni disponibile sullo stato delle navi, che venivano classificate in relazione alla loro efficienza complessiva tenendo conto dell’età, delle condizioni dello scafo e delle vele, delle attrezzature di bordo e così via. Elementi questi fondamentali per le compagnie di assicurazione che erano, e sono, chiamate a coprire i relativi rischi. Era evidente che il proprietario di una nave uscita da un cantiere rinomato, ben equipaggiata e riconosciuta idonea al trasporto di merci o di persone, poteva legittimamente richiedere di pagare un premio assicurativo più basso di quello di un’altra nave non in possesso di quei requisiti. Ma anche per comprare o per vendere un vascello di seconda mano diventava importante conoscerne il grado di efficienza o gli eventuali difetti. D’altronde anche i mercanti erano più propensi ad affidare i propri preziosi carichi a navi dichiarate sicure che, a loro volta, vedevano così migliorare i propri affari. Insomma, la novità interessava tutti. Ma perché venissero messi d’accordo tutti questi interessi contrapposti, occorreva che il Registro fosse assolutamente indipendente e autorevole. Forse fu anche per questo motivo che la proprietà del Lloyd Register non era dell’editore del bollettino, a cui interessava unicamente incrementare le sottoscrizioni, ma era condivisa fra gli stessi clienti della coffee house, persone del settore, individui, insomma semplici nomi, quei names che, sottoscrivendo personalmente la copertura dei rischi di chi va per mare, avevano nel frattempo dato vita al più grande e singolare mercato di assicurazioni del mondo: i Lloyd’s di Londra. Il Registro inglese rimase per molti anni l’unico riferimento per il mondo marittimo internazionale, finendo inevitabilmente per penalizzare le flotte degli altri Paesi, per l’ovvia tendenza a favorire il naviglio di casa.
E nel 1861 anche l'Italia si dotò di un proprio registro navale
Con lo sviluppo della marineria in Europa e in America e la crescita d’importanza degli interessi armatoriali ed assicurativi, le più importanti nazioni marinare pensarono così di dotarsi di un proprio autonomo Registro di Classificazione. Sull’onda della ormai realizzata unità nazionale, il Registro Italiano nacque nel 1861, prima delle analoghe iniziative americana, norvegese, tedesca e giapponese. Quell’anno la flotta italiana – Venezia e Roma escluse - contava ben 16.500 navi (metà della flotta inglese), ma solo 340 decisero di essere classificate dal Registro Italiano. L’inizio dunque, non fu facile. Nonostante la ragione sociale, il Registro era ancora una istituzione sostanzialmente genovese: l’80 per cento dell’esiguo numero di navi iscritte inalberava la bandiera sarda. D’altronde era qui che già da 40 anni il tipografo Pellas aveva fondato un giornale che si avvicinava in qualche misura al bollettino del signor Lloyd, riportando quotidianamente gli arrivi e le partenze delle navi, i mercuriali, i noli, i resoconti delle navigazioni. Il foglio di Pellas si chiamava “Corriere Mercantile” e fu il primo ad annunziare entusiasticamente la notizia del neonato Registro. A Genova aveva pure sede la Mutua Assicurazione Marittima Italiana, anch’essa di recente costituzione, che, per le ragioni che abbiamo visto, guardava con molto interesse la nascita di un Registro di Classificazione nostrano, al punto da sponsorizzarne la costituzione e di farvi confluire tutte le navi da essa assicurate. I Registri navali hanno avuto un ruolo determinante nello sviluppo della marineria mondiale realizzando, insieme alle rispettive flotte nazionali, un circolo virtuoso fatto di affidabilità delle navi, miglioramento della sicurezza e della qualità della vita a bordo e, quindi, riduzione dei costi e raggiungimento della capacità di competere. I frutti del lavoro plurisecolare dei Registri e la continua innovazione tecnologica che ha sempre più e meglio guidato i marinai attraverso le oscure acque dell’oceano sono oggi quasi inavvertiti, ritenendo scontati gli standard di qualità e di sicurezza a cui il passeggero del Terzo millennio non potrebbe rinunciare. Ma, naturalmente, non è stato sempre così.
Testo di Giorgio Grosso pubblicato sul numero 39 di Arte Navale. Su gentile concessione della rivista Arte Navale. Le immagini d'archivio sono pubblicate su gentile concessione della rivista Arte Navale. E' fatto divieto per chiunque di riprodurre da mareonline.it qualsiasi immagine se non previa autorizzazione direttamente espressa dall'autore delle immagini al quale spettano tutte le facoltà accordate dalla legge sul diritto d'autore, quali i diritti di utilizzazione economica e quelli morali.