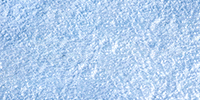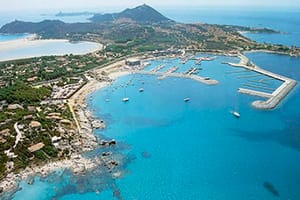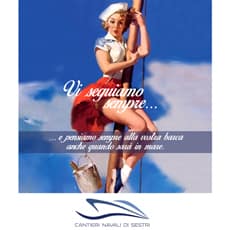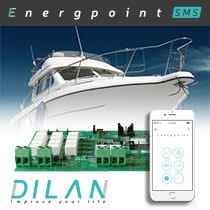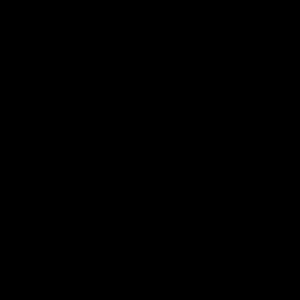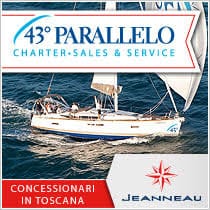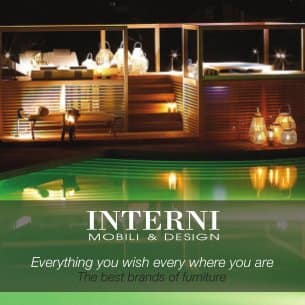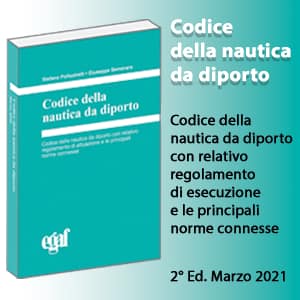Isotta Fraschini, nata in terra
cresciuta in cielo, consacrata in mare

Nei suoi tempi pionieristici l’automobile era un giocattolo di lusso che potevano permettersi in pochi. A Milano, negli ultimi anni dell’Ottocento, la passione per l’automobile era già abbastanza diffusa tra le famiglie benestanti e non era raro vedere nei viali della città due vetture misurarsi in velocità. Erano corse estemporanee, un tacito guanto di sfida che gli automobilisti si lanciavano quando si incontravano per strada, né più, né meno di quanto fanno molti velisti che si incontrano in mare e tacitamente si ingaggiano. Fu probabilmente durante una di queste sfide cittadine che si trovarono per la prima volta Cesare Isotta e Vincenzo Fraschini. Isotta, nato a Omegna, sul Lago di Orta, nel 1870, era laureato in giurisprudenza,
ma non aveva mai esercitato la professione forense; Vincenzo Fraschini, milanese, era il terzo di tre fratelli, di una famiglia di medio-piccoli industriali che operavano nel settore della laminazione di metalli non ferrosi. Cesare e Vincenzo erano appassionati di automobilismo e avevano già partecipato a qualche gara, per esempio sul circuito del lago Maggiore. Tra i due nacque un’immediata amicizia che si consolidò prima con una società negli affari e poi con una parentela acquisita, dal momento che si trovarono a sposare due sorelle, Maria e Dolinda Bianchi Anderloni. Ma ancora più curioso è che la terza sorella, Carla, era già andata in sposa ad Antonio, fratello di Vincenzo. I due amici decisero di mettersi insieme nel nascente e promettente mercato dell’automobile e iniziarono l’attività importando dalla Francia vetture Renault.
L'Isotta Fraschini nacque come azienda importatrice di automobili Renault
La società fu ufficialmente costituita a Milano il 27 gennaio 1900 con il nome di Società Milanese Automobili Isotta Fraschini & C. Gli altri soci erano i fratelli di Vincenzo, Oreste e Antonio, Riccardo Bencetti, Paolo Meda e Ludovico Prinetti. Nel 1902 la casa milanese iniziò la produzione di automobili in proprio, ma il grande salto qualitativo avvenne nel 1905 con l’assunzione di un giovane e geniale tecnico, Giustino Cattaneo. La società, intanto, aveva cambiato il nome in Fabbrica Automobili Isotta-Fraschini e si era trasferita in via Monterosa in un ambiente più vasto e meglio organizzato. Cattaneo, non ancora ventiquattrenne, era nato a Caldogno, in provincia di Vicenza, e dopo aver conseguito il diploma cum laude in studi tecnici, fu assunto dalla Società Italiana Bernardi di Padova, dove maturò le prime esperienze nell’industria automobilistica, per poi passare prima alla Florentia e poi alla Züst di Intra, sul Lago Maggiore, che voleva affiancare alla sua produzione di macchine agricole anche quella delle automobili. Cattaneo creò un telaio per auto da turismo sul quale montò un motore verticale anteriore a 4 cilindri da 40 cavalli e con uno di questi motori una Züst arrivò terza alla leggendaria corsa New York-Parigi nel 1908. Fu a Intra che Cattaneo, forse ispirato dalla sede lacustre degli stabilimenti, si cimentò nella realizzazione di un motore da 40 cavalli con invertitore, uno dei primissimi propulsori nautici di costruzione italiana. Il progetto rimase isolato ma rappresenta un’anticipazione del grande interesse di Cattaneo per la propulsione marina, interesse che si svilupperà in seguito con l’Isotta Fraschini.
Nel 1914 la Regia Marina chiese all'azienda milanese i motori per equipaggiare i MAS
Nella fabbrica milanese il giovane tecnico si affermò rapidamente e divenne il direttore tecnico, contribuendo a grandi successi sportivi che ebbero vasta eco internazionale. In 28 anni di lavoro all’Isotta Fraschini, Cattaneo ha progettato 36 modelli di automobili, tra i quali la Tipo 8, che fu la prima auto ad avere un motore a otto cilindri costruito in serie e diventando la massima espressione di lusso e di eleganza del mondo dell’auto. Industriali, divi del cinema, finanzieri, miliardari, tutti vollero una Isotta Fraschini che divenne il blasone di famiglia. Oltre alle automobili, il tecnico veneto, che nel 1925 ricevette la laurea in ingegneria honoris causa, progettò anche 19 tipi di veicoli industriali e militari, 18 tipi di motore per aereo e 15 marini. Il primo motore aeronautico fu il tipo V.1 da 80 cavalli montato sui cosiddetti dirigibili Forlanini. Da questo prototipo derivarono i potenziati V.4 e V.4B da 160 cavalli a 6 cilindri in linea con raffreddamento a circolazione d’acqua e i V.5 da 240 cavalli che equipaggiarono gli aerei dell’Esercito e della Marina Militare durante la Prima guerra mondiale. La Grande Guerra segnò anche l’inizio della proficua collaborazione della Isotta Fraschini con la Marina Militare. Lo Stato Maggiore della Regia Marina aveva avviato prima del 1914 degli studi per l’impiego di motobarche armate di siluri, dette anche autoscafi siluranti. Lo scoppio della guerra, il 5 agosto 1914, dette un’accelerazione ai tempi di realizzazione e fra i vari progetti presentati, quello dell’ingegner Attilio Bisio della Svan (Società Veneziana Automobili Navali) fu ritenuto il più idoneo alle esigenze della guerra in Adriatico. Bisio proponeva motoscafi in legno con carena a spigolo delle dimensioni di 16 metri di lunghezza per 2,6 metri di larghezza e un pescaggio di circa un metro. Per la motorizzazione la Regia Marina si rivolse alla Isotta Fraschini chiedendo la fornitura di motori a benzina di una potenza compresa tra 250 e 350 cavalli che avrebbero dovuto fornire una velocità di 30 nodi. Cattaneo si mise al lavoro con entusiasmo e in breve marinizzò un motore di tipo aeronautico, chiamato L56, a 6 cilindri, che erogava una potenza di 230 cavalli, un po’ inferiore quindi alle richieste. Non potendo più perdere tempo, la Regia Marina ordinò alla Svan la costruzione immediata di due unità che assunsero la denominazione di MAS, acronimo di Motobarca (o motoscafo) Armata Svan.
I primi MAS erano troppo lenti, ma nel giro di un paio di anni si ottennero i risultati sperati
I primi due esemplari furono consegnati e provati all’inizio dell’estate del 1915, ma ancor prima che fossero terminati gli esperimenti la Marina si vide costretta, per il precipitare degli eventi, a ordinare la costruzione di altre 50 unità per coprire le esigenze difensive per la caccia ai sommergibili nelle zone costiere. I primi due MAS si rivelarono una de- lusione, soprattutto perché la velocità che raggiungevano era di appena 23 nodi, il che ne escludeva di fatto la possibilità di un impiego offensivo silurante. La ridotta velocità dipendeva in parte dalla scelta della carena a spigolo, invece di quella idroplana a gradini che era stata valutata inadatta alle caratteristiche del mare Adriatico sempre soggetto a mutevoli condizioni meteomarine. Ma in gran parte era causata dall’eccessivo peso dei lanciasiluri e quando questi furono sostituiti con l’impiego dei telai a tenaglia, la situazione migliorò e la seconda serie di MAS si rivelò idonea all’uso offensivo, cioè silurante. Ricordiamo l’impresa del MAS 9 comandato dal tenente di vascello Luigi Rizzo che nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 1917 penetrò nel porto di Trieste silurando e affondando la corazzata austriaca Wien. Questa seconda serie, comprendente 20 unità, fu classificata come Motobarca (o motoscafo) Anti Sommergibile, conservando la sigla MAS. Rimaneva comunque il problema della velocità ancora lontana dai desiderati 30 nodi. La situazione ebbe un ulteriore miglioramento con il nuovo progetto di scafo realizzato dall’ingegner Orlando di Livorno. Con questo nuovo motoscafo e la nuova versione L250 del motore Isotta Fraschini, portato a 250 cavalli, si arrivò ai 27 nodi. A questa nuova serie varata nel 1917 appartengono i MAS 94, 95 e 96 protagonisti della Beffa di Buccari.
Fra gli innamorati della Isotta Fraschini in terra, in acqua e in cielo, c'è anche Gabriele D'Annunzio
A questa azione partecipò, com’è noto, anche Gabriele D’Annunzio, grande innamorato della Isotta Fraschini. L’Immaginifico, amante com’era del lusso e dell’estremo, non si era negato una Tipo 8, ma anche in guerra, nelle sue tante audaci imprese, per cielo e per acqua, il suo legame con l’Isotta Fraschini sembrava idissolubile. Nel volo su Vienna era a bordo di un biplano Caproni Ca.33 con 3 motori IF V.4B; di Buccari si è detto. In una delle sue solite appassionate lettere, D’Annunzio descrisse tutta la sua ammirazione per i motori della casa milanese. Finita la guerra, l’Isotta Fraschini rimase fornitrice privilegiata della Regia Marina e si può dire che questa attività servì ad attenuare la profonda crisi che investiva il mercato dell’automobile e che non aveva risparmiato la fabbrica di via Monterosa. Paradossalmente fu in questo periodo (1919) che fu creata la citata Tipo 8, ma evidentemente le spese di gestione erano superiori agli introiti e la Società aveva bisogno di continue ricapitalizzazioni. Nel 1923, intanto, anche la neocostituita Regia Aeronautica Italiana si rivolse alla Isotta Fraschini per avere un motore avio da 500 cavalli.
I primi MAS erano troppo lenti, ma nel giro di un paio di anni si ottennero i risultati sperati
Cattaneo compì allora quello che possiamo definire il suo capolavoro motoristico realizzando il famoso Asso 500 a 12 cilindri a V, 500 cavalli, che ebbe diffusione mondiale e che andò ad equipaggiare l’idrovolante Savoia Marchetti S.55 con il quale Francesco De Pinedo effettuò il raid delle due Americhe compiendo la doppia traversata dell’Atlantico. Da questo motore derivarono poi in rapida successione l’Asso 750 a 18 cilindri, 750 cavalli e l’Asso 1000 a 12 cilindri a V, 1000 cavalli, che fecero meritare a Giustino Cattaneo la laurea honoris causa. L’Asso ebbe anche applicazione marina. A contribuire alla sua marinizzazione fu il figlio di Giustino, Guido, che aveva ereditato dal padre la passione per l’ingegneria motoristica e che era particolarmente attratto dalle gare motonautiche. Ad avvicinarlo alle corse sembra che sia stato il conte Theo Rossi di Montelera, nobiluomo torinese, Re del vermouth come lo chiamavano gli americani, e primo pilota a laurearsi campione del mondo nel 1938. Guido aveva un rapporto di lavoro, oltre che di amicizia, con il conte, in quanto gli faceva da meccanico e da secondo pilota in diverse competizioni, tra le quali il raid Pavia-Venezia a bordo di idroscivolanti motorizzati Isotta Fraschini.
Con il motore Asso la Isotta Fraschini entrò nel mondo della velocità sull'acqua
Non è chiaro quando fu usato per la prima volta un Asso Marino. È certo, però, che il 26 ottobre 1929 Theo Rossi stabilì a Gardone il record di velocità della classe entrobordo 12 litri raggiungendo la velocità di 106,165 chilometri orari e che il suo racer Montelera era uno scafo Celli con motore Asso M. 12. Questo motore di tipo speciale per racer era una derivazione dell’Asso 1000 con 6 cilindri, 11.940 cc e una potenza di 350 cavalli. Con lo stesso motore, ma su uno scafo Baglietto, fu Antonio Becchi, nel 1931, il primo pilota italiano a conquistare il record mondiale di velocità della 12 litri, la classe massima, diciamo la Formula 1 di quegli anni. Becchi, sulla base misurata di Gardone, stabilì il limite di 109,898 chilometri orari. Due anni dopo, sempre a Gardone e sempre sul Lia III, migliorò il suo record portandolo a 111,202 chilometri orari. La lotta per il primato di velocità era in quegli anni una sfida privata tra italiani e francesi e fu infatti il più grande campione francese dell’epoca, Maurice Vasseur, a strappare a Becchi il record appena conquistato, con un tempo, oltretutto, strabiliante che superava di 14 chilometri orari il limite dell’italiano. Vasseur infatti, a Vitry, sulla Senna, con il suo Yzmona V, un racer Chauvière motorizzato Hispano Suiza portò il record a 125,170 chilometri orari. Ma le sorprese del 1933 non erano ancora finite. A questo punto entrava in scena Guido Cattaneo.
Nel 1933 un Baglietto motorizzato Asso raggiunse la velocità di 133,818 chilometri orari
Toltasi la tuta da meccanico e indossata quella da pilota, il giovane ingegnere, quasi sconosciuto al grande pubblico, scendeva in acqua con uno scafo di Baglietto che aveva battezzato Asso, evidentemente in onore del suo motore, il quale era un M.12 C, cioè un M.12 con compressore che erogava una potenza di 470 cavalli. Lo scenario era quello dei grandi eventi motonautici: Venezia. Dopo due tentativi abortiti per banali guasti, al terzo tentativo riuscì a compiere i quattro regolamentari passaggi sulla base misurata e la media delle medie fu sorprendente: 133,818 chilometri orari. Sceso dallo scafo e attorniato da una folla festante, si limitò a dire: «Lasciatemi andare, devo dare la notizia al mio vecchio genitore». Così chiamava scherzosamente il grande padre Giustino. A questo record ne seguirono altri. I motori marini Asso continuarono a dominare la scena motonautica fino allo scoppio della Seconda guerra mondiale e toccarono l’apice del successo con il titolo mondiale vinto da Theo Rossi di Montelera, come abbiamo già accennato. La collaborazione di Guido Cattaneo con Vittorio Vincenzo Baglietto si era intanto consolidata e i due lavoravano in perfetta sintonia. Baglietto progettava con il concorso di Cattaneo gli scafi da corsa e li costruiva nel suo cantiere di Varazze. Da qui venivano trasportati alla Cabi, l’azienda meccanica fondata da Guido alla quale si era associato il padre Giustino. Alla CABI si procedeva al montaggio di tutte le parti meccani- che fino all’allestimento finale.
La società, sommersa dai debiti, chiuse definitivamente i battenti nel 1949
Gli Asso marini furono adottati anche dalla Regia Marina per una nuova serie di MAS. Con gli Asso M.500, 12 cilindri a V di 60°, e una cilindrata di 27.710 cc fu equipaggiata una serie di 5 unità, varata tra il 1930 e il 1932 e classificata come Tipo Svan velocissimo da 14 tonnellate; la velocità era di 40 nodi. Dal 1936 la Marina si affidò completamente agli Asso 1000, che prodotti nei modelli ASM 180, 181, 182 e 183, con potenza massima variabile tra i 1000 e i 1250 cavalli dovevano diventare il tipo di motore standard dei MAS e delle motosiluranti (MS) italiane della Seconda guerra mondiale. Negli stessi anni l’industria automobilistica che aveva reso famosa nel mondo l’Isotta Fraschini era ormai entrata in una crisi irreversibile e nel 1949 il Fondo per il Finanziamento dell’Industria Meccanica, principale creditore della società milanese, decise di chiudere l’azienda. All’Isotta Fraschini rimangono legate le più belle pagine sportive e belliche della storia d’Italia sul mare. Nata in terra e cresciuta in cielo, possiamo dire che ha trovato nell’acqua un elisir di lunga vita. I motori marini Isotta Fraschini sono infatti ancora oggi ai primi posti nell’uso sportivo e in quelli per impiego militare. Una lunga storia che sembra non avere fine.
Testo di Riccardo Magrini pubblicato sul numero 46 di Arte Navale. Su gentile concessione della rivista Arte Navale.Le immagini sono pubblicate su gentile concessione della rivista Arte Navale. E' fatto divieto per chiunque di riprodurre da mareonline.it qualsiasi immagine se non previa autorizzazione direttamente espressa dall'autore delle immagini al quale spettano tutte le facoltà accordate dalla legge sul diritto d'autore, quali i diritti di utilizzazione economica e quelli morali.